
DISEGNI DI BEATRICE (2010)

Beatrice ricerca l’ombra, fa emergere da essa i caratteri intensamente personali della sua esperienza, la realtà esteriore è soltanto un punto di partenza, in nessun caso fine a se stessa. Scruta nella penombra della coscienza, porta in superficie il suo segreto e, dopo aver riprodotto accuratamente oggetti del mondo esteriore, cerca equivalenti alle proprie emozioni fra la tensione dell’oscurità e lo scoppio della luce.
Marcel Proust ne Il tempo ritrovato ha affermato che chi si contenta di descrivere le cose, dando di esse un semplice compendio di linee e di superfici, le impoverisce irrimediabilmente, interrompe ogni possibilità di elevare lo spirito nella regione del mistero. «Veri parassiti dell’oggetto coltivano l’arte in un ambito esclusivamente visivo, chiudendo a tutto ciò che sarebbe in grado di imprimere, anche nelle cose più modeste, la luce della spiritualità». E Odilon Redon, se da un lato incita a tenere gli occhi aperti sugli aspetti della realtà concreta, senza la quale ogni concezione resterebbe allo stato di astrazione, dall’altro apre all’immaginazione, all’imprevisto dei nostri sogni, senza i quali l’opera d’arte non avrebbe alcuno scopo.
Associando forze consce e inconsce, Beatrice allea espressioni plastiche singolarmente coerenti ad affascinanti moti di vita segreta. I suoi disegni si impongono per la certezza del tratto, la capacità di operare una metamorfosi del quotidiano attraverso immagini che emergono improvvise. Lo sguardo fissa le forme della natura e le spoglia, rivelandone l’ambiguità e l’artificio, sottraendole a ogni accidentalità. Presenze imperiose e sigillate sono connotate da un’elusività che allea gamme tonali e strutture grafiche legate a una realtà attentamente osservata a un mondo fantastico.
quotidiano attraverso immagini che emergono improvvise. Lo sguardo fissa le forme della natura e le spoglia, rivelandone l’ambiguità e l’artificio, sottraendole a ogni accidentalità. Presenze imperiose e sigillate sono connotate da un’elusività che allea gamme tonali e strutture grafiche legate a una realtà attentamente osservata a un mondo fantastico.
Sono disegni muti, misteriosi, dotati di un loro esoterismo, sorprendenti per intensità, esemplari di un lavoro casto e severo, che mira a compiere, con pazienza e tenacia, un’indagine in profondità, dove la forma non è nel tratto, ma all’interno di esso. Lavoro solitario, privo di corrispondenze dirette, animato da una disciplina volta a rincorrere una verità che appare protetta da un suo segreto. La scelta del disegno conferma la nobiltà di una tecnica esaltata da Ingres come «meraviglia dello spirito umano» e la predilezione per il nero – sorprendentemente definito da Renoir come «il più bello dei colori» – è la stessa che ha aiutato Redon a individuare la natura dell’invisibile.
Fogli ora lisci, ora scabri propongono immagini di conchiglie, di cardi puntuti, qualche vaso, bottiglie di matrice cézanniana, piccole ciotole, fogli accartocciati, foglie secche. Conchiglie dalle forme compatte e armoniose, felici in una perfetta, barocca rotondità, risultano talora corrusche nella ferocia di dentate mostruosità. Una di esse, fra le più belle, è dedicata a Osip Mandel’štam, il grande poeta e dantista russo, vittima della rivoluzione, che in una sua lirica paragona sé e la sua sofferenza a «una conchiglia senza perle» gettata nella voragine dell’universo. Una sintesi poetica di rara efficacia si individua ne La cena (2006), disegno che evoca con depurata semplicità e riflessi cangianti l’episodio evangelico. E, a concludere l’arco di un rapporto con una natura ricca di significati traslati, è il brillio drammatico della Corona di spine (2006), sigillo sintetico ed emblematico di una straordinaria avventura di dolore e di amore. Emile Zola ha sostenuto che l’arte può essere considerata come «esperienza della vita filtrata attraverso un temperamento». E l’arte di Beatrice denota un acuto senso di introspezione, testimoniato anche da quell’occhio che nell’Autoritratto a 40 anni (2006) sembra scrutare il mondo ma, soprattutto, scruta se stessa.
PER BEATRICE (2023)

Nel suo recente lavoro, l’artista si rapporta con inedita tensione ad alcune opere di Auguste Rodin e alla pietà Rondanini di Michelangelo. Complessa esperienza che lascia una traccia profonda sia nella conquista di valori volumetrici riferiti a Rodin, sia in una più radicale sottrazione nei confronti dello smisurato grumo di amore e dolore insito nell’estremo capolavoro michelangiolesco. “Esattamente questa è diventata, con il tempo, la mia esperienza disegnativa: da un approccio più analitico e dettagliato, negli anni della mia giovinezza, sono gradualmente giunta ad una visione sempre più “scultorea” dell’immagine, attraversata e definita dalla luce e dall’ombra”, ella afferma. Eleva la sua attività basandosi su principi fondanti quali la rodiniana nozione di “estetica delle rovine” e il fascino del volume scultoreo trasmesso nell’esortazione agli artisti e formulato nel testamento di Rodin.
Il mito è riattualizzato in funzione di una lettura contemporanea di storie relative a figure come Danaide, Faunessa, Centauressa e Cariatide con urna, tutte realizzate dal 2016 al 2021.
Sola e stremata nell’oscurità degli Inferi la Danaide di Rodin è condannata a riempire eternamente d’acqua un’incolmabile botte forata. Lo scroscio impetuoso proveniente dall’anfora si mescola alla grande massa dei capelli, quasi ad anticipare la sorte finale della trasmutazione della creatura in acqua. Per Beatrice il nero è elemento generatore, l’immagine pur iscritta nell’oscurità di una dimensione atemporale, perde ogni aspetto tragico, esclude il supplizio, assomma le forme ed elude lo spasmo espresso da un volto angosciato. Gli elementi rodiniani sono sintetizzati, non si adotta la ferocia né la disperazione di fronte ad un esito definitivo. Istituendo un paragone, nell’uno il blocco di marmo funge da strumento che assume tutte le esigenze di una drammatica corporeità, nell’altro interviene la morbidezza di un’assunzione più generosamente pietosa. Un più netto ricordo del marmo rodiniano è presente nella figura della Faunessa, anche se la frontalità è sostituita da una visione dorsale duttilmente articolata, seppure consistente, secondo l’esigenza di un disegno dotato di rotondità vagamente plastiche ed elevate levità. L’astanza del bronzo è addolcita dal ricorso ad una rapsodica penetrazione della luce che batte in alcuni punti e cede in altri al mistero.
Nella Centauressa, mirabile scultura in diretto rapporto con la poesia dantesca, Rodin evidenzia il confronto fra corpo e anima nella trasformazione dell’immagine di un cavallo in giovane donna. La fantasiosità dell’insieme è echeggiata nel disegno, attraverso una rapida summa di passaggi fondamentali come sempre assorbiti ma arricchiti dalla presenza di un nero che penetra con aerea levità. Ogni rappresentazione del corpo è trascurata e lo slancio dell’anima è assunto come segnale del simbolico dominio di un’energia di matrice spirituale. Nato dall’ombra, il disegno ripercorre l’audacia del gesto che lascia emergere dal corpo del cavallo le membra femminili lanciate verso l’alto in un respiro largo e appagante. Squarci misteriosi solcano le estremità dell’opera formando piani che sembrano spostarsi liberamente nello spazio.
Rodin mostra una Cariatide accovacciata che sostiene il peso fisico e morale di un’urna, resa nella Cariatide con urna di Beatrice quasi elemento etereo, impalpabile, mentre al corpo sono restituite rotondità e solidità volumetriche.
Nel disegno dedicato alla Pietà Rondanini di Michelangelo, si rileva un’estrema sublimazione dell’incontro di amore e dolore in un abbraccio che sembra ridurre i due corpi ad una inscindibile disperata unità. Beatrice avverte la necessità di una penetrazione rapsodica, indizio di un’urgenza creativa continuamente messa in gioco di fronte alla totalità di un capolavoro, pochi tratti possono renderla. Scultura estrema come estremo è il gesto che ne riproduce alcuni elementi: il frammento di un drappeggio, il volto dolente della Vergine, un indistinguibile volto del Cristo e il segnale di una mano ad indicare la totalità di un abbraccio. Il capolavoro pretende il rispetto di un’assoluta integrità, chi guarda può soltanto essere illuminato da pochi spezzoni colti da un’immagine eterna.
In una dimensione di estrema riduzione ma anche di intensa concentrazione è l’Autoritratto a 55 anni. Summa che non smentisce il gusto di una rivendicazione di autonomia e di energia vitale. Gli occhi perlustrano ciò che ci circonda e l’intorno è valorizzato dalla penetrazione dello sguardo. La vita è nelle cose che amiamo e che rappresentiamo come oggetti della nostra quotidianità in una dimensione libera e felice. Beatrice guarda ma non si perita di dare allo sguardo il valore di un gesto alto, riflesso di una coscienza che sia sostanza di verità.
A testimonianza della presenza simbolica del quotidiano citiamo un succoso Melograno giunto attraverso lo schermo del computer, simbolo di un’appagante ricchezza della natura, portatrice di piccole gioie sorgenti di serenità e umanità degli affetti. Siamo passati dalla sfida di un rapporto con i grandi valori, ad oggetti del nostro esistere, anch’essi dotati di significati profondi.
Ciò testimonia felicemente della necessità creativa e della fresca inventiva nel prezioso mondo onirico di Beatrice.
LA LUCE DELLA NOTTE (2001)

La manifestazione folgorante di una luce che nasce dal buio colma il pensiero compositivo dell’opera di Beatrice Cignitti. Come se, nottetempo, ella avesse avuto un contatto visivo con il sogno della sua pittura, il nero delle matite su carta si rende veicolo di una luce che in condizioni diverse sarebbe stato difficile immaginare.
La poesia di Beatrice Cignitti è quella dei silenzi delle cose immobili; cose semplici, tanto semplici, che, però, nello sfarzo dei giochi chiaroscurali si colmano di mistero, divengono elementi di un formulario magico, acquistano un’identità altra da quella delle proprie origini.
Nel solco di una tradizione italiana, che da Morandi arriva sino a Ferroni, Beatrice Cignitti aggiunge all’ambito delle vite silenti, nei suoi disegni alteri, il senso di una provenienza da un’altra dimensione, da un altrove che è proprio del mondo delle idee. Delle idee ossessive che necessitano di una continua ripresa di attenzione, nella  diversità della collocazione e delle combinazioni, per ottenere il raggiungimento della reale comprensione della loro forma e composizione materica. L’occhio di Cignitti è un occhio di assoluto pittorico: al vero pittore interessa sempre e principalmente la luce. E, aggiungerei, l’ombra che ne deriva. Per lui le cose sono quello che sono e acquistano importanza e valore solo a fronte della loro posizione rispetto a una fonte luminosa.
diversità della collocazione e delle combinazioni, per ottenere il raggiungimento della reale comprensione della loro forma e composizione materica. L’occhio di Cignitti è un occhio di assoluto pittorico: al vero pittore interessa sempre e principalmente la luce. E, aggiungerei, l’ombra che ne deriva. Per lui le cose sono quello che sono e acquistano importanza e valore solo a fronte della loro posizione rispetto a una fonte luminosa.
Ecco, quindi, che inevitabilmente la scelta narrativa tende al riduzionismo. Pochi elementi in campo, pochi oggetti su cui l’osservazione metodica e assoluta dell’occhio di Cignitti eleva a potenza l’ossessione di uno scavo in profondità, in quella che potrebbe essere la “psicologia dell’oggetto”. Una bottiglia, dunque, una conchiglia, tradizionalmente, e poi una ceramica berbera, una aggiunta “esotica”, lievemente straniante la messa in scena degli elementi. In questo contesto di riduzione, Beatrice Cignitti mette alla prova e potenzia la capacità naturale del suo sguardo di creare sospensione, un continuo stato di attesa che non sapresti dire da cosa possa specificamente nascere, ma che avverti come uno stato d’animo inevitabile. Sarà lo scavo nel buio e nel nero di una grafite che esibisce frottage, tessitura da incisore che vede il mondo attraversato dall’intreccio dei segni stabiliti dal proprio strumento; sarà che ti domandi il reale luogo di provenienza della luce, la fonte non facilmente individuabile; o anche l’emissione dell’aura posseduta dagli oggetti stessi, e che nei disegni a matite colorate appare d’improvviso, flagrante… Ma ti sembra di immediata comprensione che non ci si può, non ci si deve arrestare a ciò che appare. Come se gli oggetti delle sue nature morte stessero lì a simboleggiare altro da sé, a darsi per metafora, a indicare che ogni cosa a questo mondo è riflesso di ben altro, che spesso ci vergogniamo di nominare, ma che è sicuramente, e se non altro, il principio creativo.
Ecco, dunque, un nodo complesso a raccontarsi, a interpretarsi. Da dove proviene la luce dei disegni di Beatrice? Più si guardano e più si è incerti a definirne l’origine; fino al punto in cui non si può più fingere con se stessi e si è costretti ad ammettere che quella luce è come lo sguardo divino che permea di vita, rendendola possibile al concepimento. Vita che genera, dunque: vita silente, pertanto, non natura morta.
Tutto questo con poco, come si è visto. Eppure il segreto è tutto qui: scoprire che la semplicità è già un raggiungimento importante, perché essere semplici non è facile. E Beatrice Cignitti, per sua umana natura, sembra riuscirci per naturale predisposizione.
OMBRE (1997)

Un visitatore attento e discreto distinguerebbe, forse, per primo il volto di Beatrice Cignitti, abilmente fissato sulla carta attraverso le modulazioni ed i passaggi del nero, agitato dagli splendori perlacei di una matita che compete con le acide nerezze delle morsure d’acquaforte.
Il viso dell’artista, quasi separato dal corpo nascosto nell’ombra, sorge come un astro velato nel cielo notturno, attraverso un addensamento di tenebre profondissime, e s’impone al centro dello spazio come il motore immobile di un universo privo di luce.
Quel volto offuscato dal tratteggio che vi si depone come una fitta e lieve cortina, è una delle rare presenze umane nelle opere dell’artista, nature morte in cui compaiono abitualmente conchiglie e vasi, piante e fiori. La pittura di Beatrice Cignitti è fatta di stesure cromatiche leggere, dominate da una luminosità intensa, in cui i colori sembrano divorare il chiaroscuro anche nelle tonalità più fredde e nelle  campiture più cupe.
campiture più cupe.
Il disegno invece, come ha già notato Guido Giuffré in suo scritto dedicato a Cignitti, appare quasi come una seconda personalità dell’artista. Le sue opere grafiche, realizzate con una tecnica abile e sperimentata, sono basate su una profonda stratificazione di segni, su una meditata complessità di tratteggio.
Nei suoi fogli saturi di grafite, coperti da un abbraccio oscuro, imprigionati tra intangibili pareti d’ombra, gli oggetti assumono una presenza diversa, una nuova centralità, misteriosamente slegate dalla percezione consueta delle cose.
I rami dei pothos e dei ciclamini si allungano e s’intersecano, definendo angolazioni inquietanti e geometrie straniate, le foglie si distendono e s’incrociano nello spazio, costruendo rigorose architetture di vegetazioni, le piante si sollevano, diradando il nero assoluto da cui sembrano avere origine.
I riflessi argentei e impalpabili delle conchiglie e dei vetri attraversano e agitano le ombre, sottili fili di luce baluginano dagli oggetti come bagliori lontani che attraversano la notte.
Tuttavia, tra i disegni immersi nelle tenebre di Beatrice Cignitti, la Natura morta con ceramica berbera (1997) sembra evocare un nuovo percorso.
In quest’opera si compie una felice unione tra disegno e pittura, realizzata grazie alle matite colorate, con cui l’artista può fondere la ricchezza cromatica alla saldezza del tratto, un connubio che può ricordare l’alchimistica congiunzione degli opposti, tra la maschile secchezza del disegno e la femminile fluidità della pittura.
Il nero risplende con riverberi di pietre preziose, un cromatismo più vivo s’infittisce tra le ombre rendendo più penetrante la definizione degli oggetti che prendono possesso dello spazio con una rinnovata stereometria. Similmente alla fase dell’opus alchemico dove i colori della coda del pavone sacro a Giunone annunciano la fine dell’oscurità della nigredo, il colore, come risorto dopo la discesa agli inferi, si fa strada tra le tenebre, con bagliori di alba boreale e annuncia una luce trasfigurata da una nuova intensità.
NOTTURNI PER MATITA SOLA (2000)

Il «posto primordiale» che anni fa, in modo memorabile. Jean Clair riassegnava al disegno, la stessa perorazione per un suo ritorno, era traccia – dopo gli anni Sessanta e Settanta e quella loro creativissima incuria che nel puro gesto di disegnare aveva visto solo inanità e obsolescenza -di una possibile rifondazione del linguaggio figurativo. e di una sua precedenza assoluta, immemoriale, rispetto alla pittura. «Colui che disegna – scriveva Clair – nutre il progetto di abolire la distanza fra se stesso e la realtà. E un passaggio. Esso appare o riappare ogni volta che l’arte si trova in un vicolo cieco o in un’impossibilità. Di qui l’nnocenza fondamentale di colui che oggi fa il progetto di disegnare. Posto davanti al mondo come se questo avesse ancora qualcosa da dirgli, e liberato dallo scetticismo dei suoi contemporanei, egli è di nuovo Tessere nudo e primitivo all’alba della civiltà. Tutto comincia con il disegno, e con esso tutto può ricominciare».
Quando Beatrice Cignitti esegue queste sue carte, così limpidamente inattuali e di una maniera che è senza difetti, compie il doppio esercizio della contemplazione e della difficoltà. Esercizio che apparirà scandaloso ai dannati della produzione e dell’accumulo e a confronto di tutta l’enorme quantità di sottoarte che li specchia, specie di creatività obbligatoria, di genere inferiore, senza approdo, senza castone. (E sembrerà eccessivo o superfluo ricordare come oggi la fotografia, e i suoi derivati dappertutto, sono rivolti sempre, in qualche modo, sul lato della morte, mentre quelle che Gino De Dominicis chiamava arti maggiori – del disegno, della pittura, della scultura – corrispondono a prove di vita, di durata?) Con quali pazienza e lentezza ed esattezza Beatrice sa estrarre ogni effetto possibile da un mezzo così semplice e povero. E non per esibire vanamente non so che bravura o destrezza – anche se poi il talento qui è evidente, e riflette l’immagine di una bambina che fin da subito si esprime bene, facilmente, solo così – ma perché esistere, per questo tipo di artisti, è tentare di svelare l’essenza dell’altro, e poco importa che questo sia una persona, una parte di mondo o soltanto un oggetto. Aggiungo che la materia utilizzata, il mezzo, come ognun sa, non è mai neutrale ma dice la sua, attingendo a chissà quali fondi segreti, Vedo che a questo proposito Cesare Vivaldi, presentando il  lavoro di Beatrice, faceva i nomi di sommi disegnatori come Seurat e Radon, giustamente, solo che il primo sappiamo quanto stralunasse il soggetto prendendone le distanze per troppo amore formale, mentre il secondo, dirigendosi in una direzione inversa, si immergeva nel buio della materia traendone vita fantastica e parecchi sogni. Beatrice è come se abbia deciso di abitare una striscia di terra più sicura, concreta, decisa a non perdersi nell’invisibile. Riprende storie già periodicamente narrate dal mondo dell’arte: storie di ripari cercati, desiderati, di spazi protetti, in disparte da tutto.
lavoro di Beatrice, faceva i nomi di sommi disegnatori come Seurat e Radon, giustamente, solo che il primo sappiamo quanto stralunasse il soggetto prendendone le distanze per troppo amore formale, mentre il secondo, dirigendosi in una direzione inversa, si immergeva nel buio della materia traendone vita fantastica e parecchi sogni. Beatrice è come se abbia deciso di abitare una striscia di terra più sicura, concreta, decisa a non perdersi nell’invisibile. Riprende storie già periodicamente narrate dal mondo dell’arte: storie di ripari cercati, desiderati, di spazi protetti, in disparte da tutto.
Difficilmente certe polarità del disegno risultano più evidenti come in questo caso: essenzialità e concentrazione, una forza che seleziona e traccia contorni anche là dove non ce ne sarebbero (perché è così che noi strappiamo all’opacità, all’inerzia ciò che vediamo) che percepisce ritmi di linee anche solo mentalmente, che isola e focalizza le immagini (la continuità del mondo, muta, assediante, è spezzata, pochi elementi sono eletti) e ne riconosce e tenta con la pressione della mano i limiti, i punti di fuga nello spazio, che antepone al caos il nitore mansueto di alcune cose, la loro parte di luce, l’ombra. Limpidamente, con chiarezza.
Solo che qui è sempre sera. Diresti: notturni per matita sola. Un piano di posa un po’ lunare, simile a un paesaggio vuoto, dove siano deposte lucide, stravaganti architetture. Una luce scura. E un’ombra – ombra che è sentimento del tempo, concorderebbe Redon – che scintilla. Poiché ricomporre su di un altro piano gli oggetti – ciò è arte – equivale a rappresentare e a immaginare, dichiarandoci fedeli alla realtà proprio nell’attimo in cui ne fuggiamo. «L’oggetto – ha scritto sulla Cignitti Guido Giuffré – resta del tutto assorbito dagli elementi della forma – essenzialmente la luce e l’ombra – che insieme lo determinano e lo trasfigurano; esso rinasce come purificato, in perfetta equidistanza tra la realtà della natura e quella dell’emozione».
Ecco allora vetri e conchiglie e ceramiche – ma perché sempre contenitori vuoti? offerte votive? in attesa? nascondigli e raccoglitori di che? – figure che si lasciano lentamente plasmare dallo spazio che le circonda, come stando in un grembo chiaroscuro. E poi rifrazioni interne della materia, sostanze mutevoli, echi, specchiature: quasi che ogni singola immagine possegga non una ma molte voci, variabili, modulate. Suoni che, non percepiti, rigano l’aria. E quando ci sono apparizioni di colori, nei lavori di Beatrice, li vede molto efficacemente Lorenzo Canova, come risorti dal buio» un’invasionee “con bagliori di alba boreale”
C’è da tremare per tanta mitezza e volontà di non cedere al disincanto. Oggi che tutto depone contro destini così. Per questo vorrei dire a Beatrice di sacrificare ancora molto, di proteggere il grado di ascesi di questi suoi disegni aprendoli su più ampi strati psicologici, di sentire vicina a sé, per esempio, l’azione profonda svolta da un artista come Gianfranco Ferroni, di essere insomma ancora più raccolta su se stessa, di sorvegliarsi quasi con cattiveria, simultaneamente assumendo davanti agli altri il piacere – e il tono – del distacco.
“ACCADEMIA 50 – GENERAZIONI TRASFORMAZIONI ATTRAVERSAMENTI”
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE
MACA PALAZZO TIRAVANTI 16 FEBBRAIO 24 APRILE 2024
 Le opere di Beatrice Cignitti sono un omaggio alla tecnica tradizionale del disegno, punto di origine delle arti visive e strumento indispensabile di riflessione e di indagine.
Le opere di Beatrice Cignitti sono un omaggio alla tecnica tradizionale del disegno, punto di origine delle arti visive e strumento indispensabile di riflessione e di indagine.
La poetica di questa artista si nutre di metodi secolari e gesti rituali; affida l’interpretazione del reale a tratti metodici e scanditi, volti a esplorare i volumi e a farli emergere ben prima dei profili. Corpi e nature morte sono osservati nella loro natura plastica messa in evidenza da un disegno marcatamente pittorico, in cui le forme sono definite per contrasto costruttivo e per contrapposizione dialettica di luce e di ombre. Da un fondo di tenebra, i corpi e gli oggetti di Cignitti affiorano in qualità di presenze luminose, masse evocative a rilievo in cui la luce si rapprende in zone ad alta luminosità fino ad operare una trasfigurazione della materia e una sua declinazione simbolica.
“Faunessa”, opera ispirata ai lavori del grande maestro francese Auguste Rodin, termine di confronto e dialogo per l’artista, e “Melograno”, esempio delle nature morte che compongono il repertorio disegnativo di Cignitti, ci avvisano della costante imperturbabilità della tradizione e ci portano a contatto con il valore trasformativo della luce, capace di trasportare in dimensioni illusorie e visionarie anche le forme apparentemente più ancorate al reale.
LE OMBRE METICOLOSE DELLA MATITA DI CIGNITTI (1997)

Beatrice Cignitti espone alla Galleria Lazzari (via di San Giacomo 22) opere titolate «Ombre». Le opere tutte realizzate a matita su carta meticolose e rare, raccontano del segno insistente sulla carta, descrivono i volumi per ombre degli oggetti in natura quando silenziosamente rapiscono lo sguardo della grafite. Calle, grande pothos, ficus, ciclamini rosso-rosa, fiori e piante catturate dall’ondeggiare del chiaroscuro sul piano del foglio, colme di rarefatta passione troneggiano alle pareti contornate da un passepartout che le stringe d’assedio: al colmo della perfezione Cignitti usa carte Fabriano F6, rare e preziose senza acidi.
Il grigio scuro della grafite ottenuto dai continui picchiettamenti della punta della matita, sempre e comunque appuntita al punto giusto, è inquieto e si ridesta compagno sodale accanto ai grigi fino al bianco della carta in rapidi guizzi di silenziose ombre. Appunto come il titolo che riecheggia lontani misteri teatrali, un silenzio assoluto, il piacere di sentire la grana della carta che assume su di sé il frastuono della composizione.
Pittrice più unica che rara Cignitti è stata allieva in tempi fulgidi per il segno e il colore di Enzo Brunori il quale sapeva fare il «maestro» e si prodigava fino alto «sgolamento» del pigmento sui valori dei toni e dei semitoni; primi piani e taglio della prospettiva cromatica. Cignitti è stata una delle allieve più interessanti e a distanza di anni lo conferma come autonoma pittrice originale di indubbio valore artistico.
Al di là del fracasso pittorico circostante, Cignitti con il giusto silenzio continua a lavorare sui valori del chiaroscuro che prende forma; nell’apparizione dell’oggetto ritratto: pianta, fiore, vaso, barattolo che sia, Cignitti inappagata continua a lavorare nella convinzione che quel che conta in arte è la «perfezione imperfetta». Le luci cambiano, le prospettive si allargano con la luce del sole e poi quella artificiale tradisce le attese: insomma come per i grandi artisti, anche per Cignitti la luce è vita per l’opera d’arte, nel suo evolversi nello spazio. Ma è nei suo accanirsi nell’opera su carta che l’artista rapisce l’evolversi della luce.
(1996)

Che Beatrice Cignitti abbia studiato con Enzo Brunori si capisce bene. Brunori, per il quale Beatrice aveva ed ha mantenuto quasi un culto, oltre ad essere il pittore che sappiamo (maggiore della sua fama) era eccellente didatta, e non ultimo suo merito era il rispetto della personalità dell’allievo. Al primo punto dell’insegnamento egli poneva l’importanza della pittura come tale, alla quale si può dedicare la vita, com’egli stesso faceva, ma di cui non si può offendere la dignità. Beatrice ha inteso bene questa lezione; e non questa soltanto.
Qualche anno fa ella impiegava un raffinato puntinismo, elaborato, calibrato, derivato certo dalla conoscenza dei precedenti storici ma soprattutto dalla propria personale sensibilità. Brunori com’è noto centellinava le infinite sfaccettature della cromia traendone quelle magie – sull’eco fantastica e poetica della natura – che ne hanno fatto un maestro. La nostra giovane artista reinventava quelle modulazioni del colore riducendole, o concentrandole, nel puntinato, o magari in certe svirgolature orchestrate – valga anche il risvolto musicale – in vere e proprie scale cromatiche. La piccola tempera di un autoritratto del ’90 (l’artista era giovanissima) riassume nella sua grazia sottile quanta malinconia (e incanto, e amore per il colore e la luce) animava allora ed ha continuato ad animare il suo lavoro.
Ma il puntinismo, sia pure rivissuto, richiamava inevitabili parentele, italiane e straniere, difficili da riproporre; e Beatrice da qualche tempo esercita le variazioni del colore in più larghe campiture, traendo a spunto motivi vegetali: tralci e foglie come pretesto per impaginazioni astratto-decorative. Nelle quali tuttavia non di rado (e sono le intenzioni più segrete e più vive) sul ritmo della forma prevale il guizzo della luce, la gola d’ombra, l’intrico di un tralcio che accende più che carezzare il colore.
Ma la pittura – terreno fertile che Beatrice dissoda e che darà frutti copiosi – pure non è ancora suo terreno d’elezione. Il luogo privilegiato è il più lontano dall’insegnamento (ma non dalla personalità) del maestro: un disegno di forti accentuazioni d’ombra e di luci vuoi appena baluginanti, vuoi nette e corrusche. Così, come avviene talora, la personalità mite e dolcissima della giovane artista trova il suo momento più acuto, e forte, e complesso, in una dimensione cupamente notturna. Brunori aveva coltivato codesto versante; soprattutto in certe incisioni – parte non secondaria del suo lavoro – protagonista era proprio il modulato rapporto luce-ombra. Ma se, nella pittura, Beatrice trova se stessa nell’eco ancora operante del maestro, i suoi disegni, dove la visione è già matura, non vengono che dal raccoglimento, e dalla tenacia, capacità di ascolto e di riflessione, e infine dimensione poetica sua propria. Con la grafite Beatrice raggiunge una densità e si direbbe una perfezione ammirevoli. L’oggetto resta del tutto assorbito dagli elementi della forma – essenzialmente la luce e l’ombra – che insieme lo determinano e lo trasfigurano; esso rinasce come purificato, in perfetta equidistanza tra la realtà della natura e quella dell’emozione; la realtà appunto trasfigurata dell’arte. La conchiglia, l’uovo, la mela, i fiori, il vaso di vetro, vivono nell’evocazione della luce che intreccia sulle superfici vicende innumerevoli, apre gole fosche, spalanca abissi, o trae imponderabili luminescenze che crescono, dilagano, esplodono in abbagli di folgori taglienti. Lo spazio non è ribalta che si ritrae lasciando campeggiare l’oggetto, né questo è personaggio che subordina a sé quanto lo circonda. L’uno non vive senza l’altro, che ne accoglie e ne protegge il respiro, gli echi, le ansie. Come gli specchi in certi quadri fiamminghi, l’oscurità che circonda queste reliquie nasconde e rivela presenze segrete; ma soprattutto sensi riposti, attese, silenzi. In questi silenzi e attese, nella magica sospensione di ogni voce o suono dell’oggi, l’oggi ritorna anch’esso trasfigurato: fatto pensiero e incantamento. Il messaggio di Beatrice Cignitti ci giunge – nel tempo che stiamo vivendo – quanto più desueto, tanto più prezioso; come preziosi e rari sono questi disegni: per la parola che pronunziano e per il suo suono ineffabile.
BEATRICE CIGNITTI METTE IN MOSTRA IL SUO MONDO IN BIANCO E NERO (2010)

Bianco e nero. Come nei film e nelle foto che oggi fan quasi archeologia. E’così che Beatrice Cignitti, giovane artista romana preferisce raffigurare il mondo che la circonda isolandone in bianco e nero le forme. Ed è così che ha deciso di ripresentarsi nella mostra che fino al 31 gennaio tiene cartello nella Galleria Andrè di via Giulia 175. Una fede incrollabile nel primato del disegno, come strumento per afferrare il visibile e l’invisibile. E un gusto controcorrente di imporre il silenzio del segno, la chiave ambigua del chiaroscuro, inseguire i capricci della luce, ritagliando lo spazio con la matita. L’effetto delle opere incluse in questa personale, presentata in catalogo da uno smagliante saggio di Maria Teresa Benedetti è sorprendente. Conchiglie, vasi, bicchieri, piccole ciotole, fiori e foglie secche: un campionario di nature morte in posa su drappi bianchi che con tratto sicuro l’autrice increspa in un moto ondoso secco e incalzante. Cimeli che la magia del bianco e nero, nitido e terso come un gioco di specchi, trasforma in misteriosi miraggi, carichi di intensità, perchè la visione prende vita da un singolare accumulo di realtà e irrealta: gli oggetti ci appaiono fermi, congelati in un tempo fuori del tempo ma sembrano vibrare sotto la superficie un respiro d’altrove a volte intimo come una confessione sottovoce a volte persino minaccioso e inquietante come una profezia.
L’ARTE DEL BUIO (2023)

Una bella mostra curata da Gabriele Simongini rende omaggio a Beatrice Cignitti, artista appartata che ha scelto il buio e il mondo delle ombre come suo terreno di ricerca. Ma sempre restando aderente alla trasfigurazione della classicità
Con caparbia coerenza, da quando ha deciso di scommettere sulla sua vocazione per l’arte e costruirci su la sua vita e la sua carriera, Beatrice Cignitti governa un regno di ombre. Lì ha eletto il suo rifugio, il suo laboratorio e il suo palcoscenico. Scelta in controtendenza, almeno per l’Occidente di oggi, così estraneo al pudore fecondo della semioscurità esaltato da un custode della tradizione giapponese, come lo scrittore Tanizaki. Un Occidente che sul culto artificiale della luce ha fondato i suoi traguardi di modernità creativa, misurando e inseguendo i progressi e lo spettacolo della tecnologia: dall’accensione dei lampioni a quella degli specchi luminosi del cinema, della tv, dei computer.
Quand’era poco più che ventenne, Beatrice Cignitti ha trovato invece nel buio la sua cifra espressiva e il suo luogo di pittrice. Restringendo sempre più al bianco e nero la sua tavolozza, il mistero della cromia condensato dalla presenza e dall’assenza fantasmatica di tutti i colori. Rinunciando al pennello per la matita, all’intensità onnivora della campitura dipinta per una ragnatela di segni sovrapposti e intrecciati, così fragile che basta un errore a dissolverla. Un lavoro di concentrazione e devozione monastica, mesi interi per raggiungere sul foglio una meta compiuta. E vedersela insieme sfuggire davanti, come succede ad ogni artista che insegue la sua verità dando la caccia all’invisibile. Oltre il confine muto della pura apparenza. Per spingersi verso quell’altrove, certo, poi servono anche dei trucchi. Il ricorso alla bicromia del chiaroscuro non basta. Per mettersi in scena attraverso forme e volumi se l’autore, come ha fatto la Cignitti, rinuncia al monologo microfono in mano, bisogna scegliere i propri attori e addestrarli. Il suo cast l’autrice lo ha composto servendosi di oggetti che la circondavano. Vasi, fiori, recipienti, bottiglie, matasse di fili, giocattoli. Il sexappeal quotidiano dell’oltreumano. All’inizio un ingaggio di comparse. Poi cimeli recitanti più estroversi e smagati, arruolati e collaudati in altri contesti, che sulla battuta trascinano il peso di esperienze, richiami di vissuto e immaginario diversi. Come le conchiglie, modellate dal respiro del mare, dal setaccio della sabbia e dell’onda in giochi di trasmutazioni infinite. Uno dei suoi leit motiv più riusciti.
Il secondo passaggio è stato quello di togliere loro e ai loro corpi l’ingessatura da nature morte. E qui è arrivato il colpo d’ala: la manipolazione della luce. Gli oggetti che Beatrice Cignitti ritrae e ha continuato a ritrarre, sfuggendo a ogni regola fisica, non si limitano ad assorbire la luce, ma la emettono a segnare e invadere di stupore lo spazio. Insomma si accendono e ti brillano davanti come filamenti di lampadine. Autorizzando lo spettatore ad ogni fuga di coinvolgimento e di fantasia. Ricordi che si ridestano, emozioni, contrappunti di musica. L’aura, un risarcimento dell’aura data da troppi per morta, che torna a impregnare di mistero e profondità, come un timbro di autenticità, l’unicità dell’opera d’arte.
Il bagliore segreto della realtà, battezza con grande acume questa tensione estetica Gabriele Simongini, critico e storico d’arte che ha accompagnato per anni il decollo e le rare, applaudite, apparizioni pubbliche di Beatrice. E ha impresso come chiave di lettura questo titolo alla mostra con cui questa autrice si ripresenta al pubblico nella piccola sala bomboniera della galleria Monogramma di via Margutta, a Roma. Per dar conto di una svolta esistenziale e creativa che sta trasformando il suo regno di ombre. Infrangendo quella cappa di solitudine che la convivenza con un universo di soli oggetti si trascina appresso. E popolando di personaggi e presenze quell’universo parallelo e transumano di riflessi emotivi e mediati nel quale si era confinata., senza mutare, almeno in apparenza, la sua tecnica e il suo stile. Come? Chiamando in scena i corpi forgiati da alcuni maestri del passato che da sempre l’hanno ispirata.
Leggendo la sua biografia si intuisce che quel salto d’ispirazione è maturato quattro anni fa, quando da allieva Beatrice Cignitti si è trasformata in docente, prima partecipando come insegnante di disegno dal vivo ai corsi della scuola di nudo dell’Accademia di Roma, purtroppo inspiegabilmente cancellati dalla nuova dirigenza, poi ottenendo una cattedra all’Accademia di Frosinone. Un’esperienza brutalmente interrotta e un nuovo compito di trasmissione di strumenti e saperi che ha svincolato e cambiato anche i suoi orizzonti d’artista. Facendo emergere un nuovo impellente bisogno, quello di impadronirsi ancor più dello spazio del foglio e incanalare il disegno verso il modellato della scultura, l’urgenza più tattile delle emozioni che il corpo umano sprigiona. E che solo il genio, la mano degli artisti più dotati sa strappare all’inerzia della pietra, del marmo. Della morbidezza inorganica della creta.
E chi più dotato dei due maestri, Rodin e Michelangelo, che in questo primo esperimento sul suo nuovo corso Beatrice ha chiamato in scena, usando, mettendo in posa e reinterpretando come modelli alcuni dei loro capolavori.
Una fase di rodaggio dichiarata come tale dalla decisione di affiancare a questi studi su icone da museo, cui è riservata più di metà della mostra, una sorta di riepilogo dei lavori precedenti affidato a una decina tra lavori mai esposti, o opere inedite realizzate di recente che continuano invece a declinare l’ingannevole spartito di “nature morte”. C’è persino una fantasmagoria di pastelli colorati, pratica in cui la Cignitti si è cimentata e poi ha lasciato in disparte.
Il primo e il dopo a confronto insomma. Inevitabile, a mio avviso, che la bilancia penda su questo secondo più praticato versante, reso più intenso da un lungo lavoro di perfezionamento e di scavo che scavalca le rigide briglie delle intenzioni, della razionalità dell’impianto, della ricerca di perfezione e consente alla pittura di dipingersi e spingersi da sola verso la soglia imprevedibile, sconosciuta del senso e del non senso del vivere. Chi ha detto che gli oggetti siano corpi più silenziosi ed inerti, abbiano meno cose da raccontare e da dire, quando l’arte li sottrae al loro destino di cose, violando le rigide gerarchie dell’uso e della convenienza che stanno precipitando verso il baratro il destino dell’umano? Che le architetture, le piazze deserte e metafisiche di De Chirico, che le bottiglie di Morandi rimandino voci più deboli, di un nudo e di un ritratto?
Sfidare i grandi del passato, confortati anche dalla sintonia con le idee che hanno espresso, comporta un rischio da soppesare: quello di restare schiavi dell’incanto per cui li ammiri, dell’ebrezza dell’aura che avvolge i loro capolavori e dimenticare, trascurare quella che tenti – che artista saresti se no… – di recuperare per altre strade con le tue reinterpretazioni. È questo pericolo che credo volessero sventare le avanguardie che più volte hanno profetizzato, invocato la morte delle Accademie. Per questo trovo formalmente impeccabile ma freddo, ammorbidito da un eccesso di devozione, l’omaggio che Beatrice Cignitti rende qui in mostra alla Pietà di Michelangelo. Troppo aggraziata, stemperata d’asprezza la torsione dei nudi che la sua matita prende in prestito alla Cariatide e alla Faunessa di Rodin. Molto più riuscito invece il movimento che restituisce a un altro capolavoro dello stesso autore, la Centauressa, facendo apparire e scomparire il miracolo di quella trasmutazione da donna ad animale, tra le quinte di un teatrino in penombra, in quella foschia di vellutato, capriccioso riserbo che è diventata col tempo la sua inconfondibile cifra d’artista e di donna, che si confessa e si nega, si fa avanti e si tira indietro allo stesso tempo, accetta di fare spettacolo ma non si presenta alla ribalta per l’applauso finale. Come in modo ancora più marcato fa in uno dei lavori più intriganti di questa mostra. Un autoritratto presentato dal titolo come un certificato anagrafico che segnala la sua età. 55 anni da poco compiuti. E impone a noi come unità di misura del suo percorso. Il buio in sala è ancora più fitto. Si intravede solo il caschetto di capelli e il rotondo inconfondibile del viso. A rubare lo sguardo sono solo i suoi occhi da demiurgo che si accendono e galleggiano ipnotici nell’oscurità.
Trasmettendo la stessa inquietudine, da scarica elettrica, che percorre i contorni dei suoi oggetti e in questi ultimi anni si è accentuata: una luce aguzza come una lama che si fa largo a spintoni, moltiplica di punti di fuga lo spazio e non tenta più di simulare un riflesso reale. L’arte come artificio, la vita come una lampadina che non sai da dove rubi energia e quando si spegnerà.
(2023)

“In tempi di insopportabile ‘armocromia’ Beatrice Cignitti dispiega invece davanti ai nostri occhi le mille sfumature che vanno dal nero assoluto al bianco, passando per i bagliori metallici dell’argento, evocato da un piccolo oggetto domestico.
Per questa artista che muove le durezze della grafite come fossero altrettante emozioni di una mano sapiente, ogni cosa piccola o grande che cade sotto il nostro sguardo è degna di attenzione, riluce di un chiarore spirituale.
Dall’impalpabile ‘nigredo’ nascono le istanze creative, si generano con mistero alchemico le molte figurazioni oniriche.
Troveremo, entrando in questo mondo, i volumi di Rodin, l’evocazione di un disegno che si fa scultura.
Ma soprattutto, avremo, a ben guardare, un sobbalzo, uno stupore, osservando una Pietà Rondanini rappresentata capovolgendone la lettura verticale; il grumo di dolore e amore che quest’opera immensa contiene è colto nell’ulteriore disfacimento della materia, nell’attimo prima in cui al tramonto la luce in una stanza sta per lasciare il posto alle tenebre.”
(1991)

La bellezza dell’entusiasmo preme e freme sotto la pelle del dipingere disegnando e del disegnare dipingendo di Beatrice Cignitti Questo stato di giovinezza mentale che coincide con questa prima giovinezza di fatto dell’artista (perché in alcuni è il contrario, infelici loro) resterebbe fìorescenza visiva senza un’altra situazione che è evidente, cioè risulta dall’opera: la bellezza della meditazione. Abbiamo come risultato fogli che vibrano di pensata gioia, di riposante corsa nella ricerca della verità poetica nelle apparenze. I fogli di Beatrice Cignitti diventano batuffoli di tenerezza e simultaneamente, ed è questo capacità d’arte, ritratti rigorosi della realtà come appare.
Il suo disegnare come il suo dipingere, e l’inverso, rischiano di diventare adulti, se non ci fosse un incantato alt, ch ‘è giovinezza poetica: l’artista scopre forme e segreti, luci e nascondigli per la prima volta: tunnel di verginità visiva, rara nell’arte dei giovanissimi di questi realistici decenni, realistici anche nelle avanguardie. Qui scatta la qualità attuale della nostra Cignitti. La nota biografica di Beatrice Cignitti include, può darsi al primo posto del suo passato e passaggio dalla vocazione alla realizzazione, il nome e la pittura di Enzo Brunori, come maestro. L’artista ne accetta con orgoglio la presenza. Che non c’è esplicita nella sua opera allo stadio di maturazione a cui sta arrivando.
Il nodulo realizzante è gomitolo proprio della Cignitti. C’è però l’avere appreso e capito, l’avere rielaborato nel proprio occhio, una limpida lezione. Brunori, uno dei primissimi ricercatori e reinventori dell’astrazione pittorica contemporanea, o dell’informale (comunque si voglia definire questa situazione di creatività italiana, autonoma) poteva anche influire soltanto formalmente sulla sua allieva. Questa, invece, con fulminazione di intuito, è andata sulla sua strada. Con alle spalle il maestro, è arrivata alla conclusione di produrre astrazione e informalità nel rigore delle luci e delle forme reali. Restano nella Cignitti le frantumazioni dello spazio in spazi inseriti nell’unità spaziale, quasi luci di vetrata divisoria e insieme unificante tra la luce di fuori e quella di dentro. La nostra Beatrice Cignitti ha inteso nel meglio il dettato del maestro. Oggi si presenta, in questa mostra di esordio o quasi, con le mani linde in offerta della propria personale vocazione, poggiata su una salda consapevolezza che l’arte è anche fatica, pazienza, scienza di misteriose esattezze coincidenti e confluenti nel mestiere del dipingere. Pure questo ha radici nell’insegnamento brunoriano. La Cignitti ha la qualità dello scatto dalla fatica dell’arte alla spensierata resa in poetica. Vedetela nei suoi spazi disegnati o dipinti. C’è più di qualcosa. C’è il richiamo all’indefinibile, attraverso il definito. In una giovanissima è un incredibile “molto”.
(2014)

“Sono io che ho suggerito la presenza di Beatrice Cignitti a questa edizione di Spoleto Arte: è una giovane disegnatrice piena di mistero che ho conosciuta anni fa, e che con  molto impegno e molta attenzione, e con una pazienza da antico pittore, da antico disegnatore, compone delle immagini di cui non capisci bene il senso, non c’è figurazione vera e propria, o c’è un’allusione a qualcosa che poi diventa pura immagine e puro pensiero.
molto impegno e molta attenzione, e con una pazienza da antico pittore, da antico disegnatore, compone delle immagini di cui non capisci bene il senso, non c’è figurazione vera e propria, o c’è un’allusione a qualcosa che poi diventa pura immagine e puro pensiero.
Volevo quindi ricordarla, avendola questa volta rivista e avendola già conosciuta”.
NEL GREMBO DELLA NOTTE (2016)
Se un giorno notturno e una notte diurna potessero abbracciarsi
“Bisogna rispettare il nero. Nulla lo prostituisce. Non deve piacere agli occhi o svegliare alcun senso. E’ l’agente della mente molto più del bel colore della tavolozza o del prisma”.
Odilon Redon
“… il disegno l’arte divina, base di ogni costruzione plastica, scheletro di ogni opera buona, legge eterna che ogni artefice deve seguire. Il disegno, ignorato, negletto, deformato da tutti i pittori moderni {…} il disegno, dico, tornerà non di “moda”, come oggi usan dire quelli che parlano di avvenimenti artistici, ma tornerà per necessità fatale, come una condizione sine qua non di creazione buona”.
Giorgio de Chirico

L’amplesso fecondo e inesauribile, talvolta conflittuale, fra luce ed ombra, fra notte e giorno, volti a dare forma al mondo, è l’autentico e sensuale protagonista delle opere di Beatrice Cignitti. E’ un’unione pulviscolare, atomistica, stretta in un abbraccio di particelle scintillanti, che danno corpo d’immagine ad un desiderio ascetico ma profondissimo. Come cantava Friedrich Schelling, “Se nella notte stessa sorgesse una luce, se un giorno notturno e una notte diurna potessero abbracciarsi, sarebbe infine lo scopo supremo di tutti i desideri”. E come sa bene Beatrice, il vero desiderio si nutre al tempo stesso di una presenza e di una assenza e quest’ultima, tramata d’invisibile, nutre i suoi disegni ed apre la porta al mistero. La memoria di un’assenza è del resto all’origine di quello che è ritenuto il mito fondativo dell’arte occidentale, basato tra l’altro proprio sul disegno: secondo una leggenda tramandata da Plinio il Vecchio nella sua “Naturalis Historia”, i Greci attribuivano l’invenzione della pittura, o meglio del disegno, ad una donna innamorata, la figlia di Butade Sicionio, un vasaio di Corinto, che per conservare un ricordo del suo amato in procinto di partire, “tratteggiò con una linea l’ombra del suo volto proiettata sul muro dal lume di una lanterna”. Così, si disegna veramente solo non vedendo o meglio, come nel caso della Cignitti, fuggendo la luce accecante del giorno per cercare le ombre della notte interiore e chiudere gli occhi per vedere, senza però rifugiarsi nel delirio della visione sradicata dalla realtà tangibile. E a tal proposito vengono alla mente i mirabili versi di Novalis, dagli “Inni alla notte”: “Ma più celesti/più ancora del brillio di tutte le stelle/ sfavillano in noi come occhi/infinite luci/ che la notte ci ha aperto nel cuore”. Su tale via, i disegni di Beatrice prendono forma come soglia fra interno ed esterno, fra visibile ed invisibile, fra apparizione e scomparsa, soprattutto nelle opere più recenti, quelle che hanno come riferimenti di partenza le sculture di Pietro Cenedella (artista bresciano del ‘900 che meriterebbe rinnovata attenzione) e soprattutto i lavori del titanico Auguste Rodin: mutatis mutandis, e pur nelle grandissime differenze di ricerca, in entrambi gli artisti emerge con chiarezza quella sorta di crescita organica della forma plastica che ha colpito Beatrice Cignitti. E d’altro canto la stessa scultura in marmo non fonda una parte fondamentale del proprio palpito vitale nella dialettica fra il bianco della materia e il nero delle ombre e dei vuoti? Se non ci si lascia ingannare dalle apparenze si scopre che il nero inseguito da Beatrice è sempre innervato dalla luce per sua mirabile natura e a ciò giova la profonda consapevolezza con cui l’artista usa la grafite, ben sapendo che essa, come ha spiegato Omar Galliani, “in origine è uno stato geologico che precede di milioni di anni, come compressione terrestre, il diamante, il minerale più puro e trasparente per eccellenza. La grafite sembra totalmente altro, appare nera come il buio, ma se la guardi è luminosa, riflette la luce”. Questo nero fotosensibile ed onnicomprensivo (non ci sono forse tutti i colori e volumi in potenza?) è fecondato da un lumen palpitante, un grembo che genera gli oggetti e le presenze che popolano il mondo intimo e appartato di Beatrice, la quale sempre più, col passare del tempo, sembra affrontare la sfida di “scolpire” questa luce nera col disegno, abolendo la linea che chiude e delimita e tentando di sottrarre all’oscurità dell’oblio quanto l’uomo e la natura hanno creato. Nelle forme affioranti dal buio, trepidanti per la propria fragilità, Beatrice Cignitti cerca conforto di fronte alla notte che incombe inevitabile sulle nostre esistenze. Incamminatasi con ascetica umiltà e ferrea tenacia, incurante delle mode, su una via che non ammette scorciatoie e che si tiene al difficile, quest’artista così sensibile (il cui stesso aspetto esteriore riflette gradevolmente la polarità “bianco/nero” del suo percorso creativo) aspira alla necessità assoluta che potrebbe unire indissolubilmente la tecnica e la materia con l’affioramento e lo svelamento del proprio essere più profondamente abissale ed autentico, in costante divenire. E’ la ricerca estenuante del creare raggiungendo quella sorta di naturalezza organica che si manifesta, ad esempio, in sommo grado nelle conchiglie, a cui Beatrice ha dedicato opere quanto mai avvolgenti, forse pensando anche alle inarrivabili riflessioni di Paul Valéry: “Un cristallo, un fiore, una conchiglia emergono dal consueto disordine dell’insieme delle cose sensibili e ci offrono stranamente unite, le idee di ordine e di fantasia, di invenzione e di necessità, di legge e di eccezione; nella loro forma troviamo, da una parte, la parvenza di un’intenzione e di un’azione che le avrebbe plasmate al modo in cui sanno farlo gli umani e, dall’altra, l’evidenza di processi a noi vietati e impenetrabili”. Valéry notava che la modalità con cui nasce la conchiglia è che “emana da un mollusco” e ciò la fa trasudare dai suoi pori sotto l’impulso di una necessità assoluta. “Forse – scriveva ancora l’insigne autore francese – quel che chiamiamo la perfezione nell’arte (che non è ricercata da tutti e che più d’uno disdegna) non è che il desiderio di trovare, in un’opera dell’uomo, questa certezza di esecuzione, quella necessità d’origine interna e quel legame indissolubile e reciproco della figura con la materia che la più piccola conchiglia mi mostra?”. Queste parole illuminanti di Valéry si adattavano perfettamente alla scultura di Rodin (come non pensare, ad esempio, a “La conchiglia e la perla”) le cui figure femminili sono le più recenti apparizioni proprio nei disegni di Beatrice, che ha colto istintivamente, nel corso del tempo, tale continuità plastico-organica fra forme necessarie: le conchiglie e le opere di un uomo che col marmo sapeva dire tutto di un corpo, fra presenza e assenza, attraverso la poetica del frammento. E così promana un eros soavemente notturno, tramato di un pulviscolo stellare, in questi corpi necessari, avvolgenti, che vien voglia di accarezzare nel buio, a occhi chiusi, prima che scompaiano, aspettando che il marmo si tramuti in carne e poi, ancora una volta, in traccia di mano che col disegno dà forma al mondo.
sempre innervato dalla luce per sua mirabile natura e a ciò giova la profonda consapevolezza con cui l’artista usa la grafite, ben sapendo che essa, come ha spiegato Omar Galliani, “in origine è uno stato geologico che precede di milioni di anni, come compressione terrestre, il diamante, il minerale più puro e trasparente per eccellenza. La grafite sembra totalmente altro, appare nera come il buio, ma se la guardi è luminosa, riflette la luce”. Questo nero fotosensibile ed onnicomprensivo (non ci sono forse tutti i colori e volumi in potenza?) è fecondato da un lumen palpitante, un grembo che genera gli oggetti e le presenze che popolano il mondo intimo e appartato di Beatrice, la quale sempre più, col passare del tempo, sembra affrontare la sfida di “scolpire” questa luce nera col disegno, abolendo la linea che chiude e delimita e tentando di sottrarre all’oscurità dell’oblio quanto l’uomo e la natura hanno creato. Nelle forme affioranti dal buio, trepidanti per la propria fragilità, Beatrice Cignitti cerca conforto di fronte alla notte che incombe inevitabile sulle nostre esistenze. Incamminatasi con ascetica umiltà e ferrea tenacia, incurante delle mode, su una via che non ammette scorciatoie e che si tiene al difficile, quest’artista così sensibile (il cui stesso aspetto esteriore riflette gradevolmente la polarità “bianco/nero” del suo percorso creativo) aspira alla necessità assoluta che potrebbe unire indissolubilmente la tecnica e la materia con l’affioramento e lo svelamento del proprio essere più profondamente abissale ed autentico, in costante divenire. E’ la ricerca estenuante del creare raggiungendo quella sorta di naturalezza organica che si manifesta, ad esempio, in sommo grado nelle conchiglie, a cui Beatrice ha dedicato opere quanto mai avvolgenti, forse pensando anche alle inarrivabili riflessioni di Paul Valéry: “Un cristallo, un fiore, una conchiglia emergono dal consueto disordine dell’insieme delle cose sensibili e ci offrono stranamente unite, le idee di ordine e di fantasia, di invenzione e di necessità, di legge e di eccezione; nella loro forma troviamo, da una parte, la parvenza di un’intenzione e di un’azione che le avrebbe plasmate al modo in cui sanno farlo gli umani e, dall’altra, l’evidenza di processi a noi vietati e impenetrabili”. Valéry notava che la modalità con cui nasce la conchiglia è che “emana da un mollusco” e ciò la fa trasudare dai suoi pori sotto l’impulso di una necessità assoluta. “Forse – scriveva ancora l’insigne autore francese – quel che chiamiamo la perfezione nell’arte (che non è ricercata da tutti e che più d’uno disdegna) non è che il desiderio di trovare, in un’opera dell’uomo, questa certezza di esecuzione, quella necessità d’origine interna e quel legame indissolubile e reciproco della figura con la materia che la più piccola conchiglia mi mostra?”. Queste parole illuminanti di Valéry si adattavano perfettamente alla scultura di Rodin (come non pensare, ad esempio, a “La conchiglia e la perla”) le cui figure femminili sono le più recenti apparizioni proprio nei disegni di Beatrice, che ha colto istintivamente, nel corso del tempo, tale continuità plastico-organica fra forme necessarie: le conchiglie e le opere di un uomo che col marmo sapeva dire tutto di un corpo, fra presenza e assenza, attraverso la poetica del frammento. E così promana un eros soavemente notturno, tramato di un pulviscolo stellare, in questi corpi necessari, avvolgenti, che vien voglia di accarezzare nel buio, a occhi chiusi, prima che scompaiano, aspettando che il marmo si tramuti in carne e poi, ancora una volta, in traccia di mano che col disegno dà forma al mondo.
IL BAGLIORE SEGRETO DELLA REALTA’ (2023)
Noi ci affanniamo sempre. / Ma il progresso del tempo / consideratelo una smagliatura / di quel che sempre resta
Rainer Maria Rilke
 Indifferente al succedersi delle mode, dei vari vetrinismi, delle fabbriche dismesse trasformate in installazioni e via discorrendo, Beatrice Cignitti continua a tessere sapientemente segni di luce umbratile che rigenerano il mondo, i corpi, gli oggetti, facendo dialogare il giorno e la notte. Come un amanuense d’altri tempi, salva il salvabile partendo dalla sapienza della mano demiurgica e senziente. Con un’ipersensibilità quasi medianica, Beatrice vede l’aura perfino in quest’inizio di terzo millennio così ferocemente tecnologico e pragmatico. È una rabdomante di magie quotidiane, semplici, e anche per questo ancora più sorprendenti. Così tutto si ammanta di un mistero avvolgente, dolce, trepidante, nella preziosa solitudine della sua vita e della sua ricerca. E sempre di più, in questi anni recenti, soprattutto nelle matite ispirate all’amato Rodin, il suo segno supera qualsiasi linearità bidimensionale per farsi plastico e costruttivo, pur conservando la sua vibrante musicalità. Lo vediamo nei tre piccoli nudi “Danaide”, “Faunessa” e “Cariatide con urna” e nella grande figura con la “Centauressa”, in cui la frequente applicazione di un’evocativa poetica del frammento emana il suono di un mondo perduto mentre il mito suggerito dalle loro pose si attualizza nel presente con una seducente carnalità. E non a caso Beatrice ama ricordare una preziosa riflessione lasciata da Rodin nel suo testamento: “Tutti i grandi sondano lo spazio. E nella nozione di spessore che risiede la loro forza. Ricordatevi di questo: non vi sono linee ma solo volumi. Quando disegnate, non preoccupatevi mai del contorno, ma del rilievo. È il rilievo che regge il contorno”. Ma i volumi immaginati da Beatrice nascono da un’irradiazione quasi atomistica e stellare innescata da un lavoro lungo, certosino, paziente, pulviscolare, che vive di un senso del tempo orientato sui ritmi vitali della natura e non su quelli assurdamente frenetici di un oggi obliante. La meraviglia dell’intimità con il soggetto scelto si unisce all’amore per lo sguardo prolungato: l’artista ci invita a contemplare pazientemente ma, allo stesso tempo, a muovere l’occhio per scoprire qualcosa di unico negli enigmi del visibile. E poi le opere di Beatrice esaltano, come quasi mai accade con altri artisti contemporanei, il senso del tocco, per così dire, un’eccellenza del tatto inteso come azione fluida e delicata, che proviene dall’interiorità, tanto da donarci l’illusione feconda di poter toccare perfino la luce e l’ombra.
Indifferente al succedersi delle mode, dei vari vetrinismi, delle fabbriche dismesse trasformate in installazioni e via discorrendo, Beatrice Cignitti continua a tessere sapientemente segni di luce umbratile che rigenerano il mondo, i corpi, gli oggetti, facendo dialogare il giorno e la notte. Come un amanuense d’altri tempi, salva il salvabile partendo dalla sapienza della mano demiurgica e senziente. Con un’ipersensibilità quasi medianica, Beatrice vede l’aura perfino in quest’inizio di terzo millennio così ferocemente tecnologico e pragmatico. È una rabdomante di magie quotidiane, semplici, e anche per questo ancora più sorprendenti. Così tutto si ammanta di un mistero avvolgente, dolce, trepidante, nella preziosa solitudine della sua vita e della sua ricerca. E sempre di più, in questi anni recenti, soprattutto nelle matite ispirate all’amato Rodin, il suo segno supera qualsiasi linearità bidimensionale per farsi plastico e costruttivo, pur conservando la sua vibrante musicalità. Lo vediamo nei tre piccoli nudi “Danaide”, “Faunessa” e “Cariatide con urna” e nella grande figura con la “Centauressa”, in cui la frequente applicazione di un’evocativa poetica del frammento emana il suono di un mondo perduto mentre il mito suggerito dalle loro pose si attualizza nel presente con una seducente carnalità. E non a caso Beatrice ama ricordare una preziosa riflessione lasciata da Rodin nel suo testamento: “Tutti i grandi sondano lo spazio. E nella nozione di spessore che risiede la loro forza. Ricordatevi di questo: non vi sono linee ma solo volumi. Quando disegnate, non preoccupatevi mai del contorno, ma del rilievo. È il rilievo che regge il contorno”. Ma i volumi immaginati da Beatrice nascono da un’irradiazione quasi atomistica e stellare innescata da un lavoro lungo, certosino, paziente, pulviscolare, che vive di un senso del tempo orientato sui ritmi vitali della natura e non su quelli assurdamente frenetici di un oggi obliante. La meraviglia dell’intimità con il soggetto scelto si unisce all’amore per lo sguardo prolungato: l’artista ci invita a contemplare pazientemente ma, allo stesso tempo, a muovere l’occhio per scoprire qualcosa di unico negli enigmi del visibile. E poi le opere di Beatrice esaltano, come quasi mai accade con altri artisti contemporanei, il senso del tocco, per così dire, un’eccellenza del tatto inteso come azione fluida e delicata, che proviene dall’interiorità, tanto da donarci l’illusione feconda di poter toccare perfino la luce e l’ombra.
Il passaggio, pur sempre coerente, da una fase più nitidamente analitica a quella attuale, plastico-scultorea, è testimoniato in mostra dal confronto fra le tre grandi carte (mai esposte finora) dei primi anni dieci (“Nautilus”, “Vetro rosso” e “Panneggio e scatola rossa”) e le opere più recenti. Nell’un caso e nell’altro, la sua “verità” è estatica, poetica ed elusiva, fatta di domande e senza risposte. Del resto, come profeticamente dice Robert Musil ne “L’uomo senza qualità”, “…la voce dei conti e dei calcoli oggi s’oppone dappertutto alla grandezza della vita, al mistero del sentimento”.
E proprio perché si intona spontaneamente a questi ultimi elementi, ora negletti, l’arte di Beatrice Cignitti sembra (felicemente, lasciatemelo dire) inattuale, fuori dal coro, vestita di una sua purezza di visione che cerca la scintillazione nelle tenebre, usando semplicemente la matita su carta. Lei si tiene al difficile, come consigliava Rilke in “Lettere a un giovane poeta” e non cerca scorciatoie basate su facili trovate. Beatrice cerca l’incanto anche guardando un caricabatterie, un panneggio, una matita, una scatola. Sa ancora stupirsi di fronte alla magia del quotidiano. Sembra accordarsi mirabilmente con quanto Rodolphe Bresdin suggeriva ad Odilon Redon facendo l’esempio del comignolo: “Vedete questo fumaiolo, che cosa vi dice? A me racconta una favola. Se avete la forza di osservarlo bene e di capirlo immaginate il più strano e bizzarro dei soggetti. Così il vostro sogno sarà vivo. L’arte è lì”. E non a caso lo stesso Redon arrivò a scrivere in “A soi-mème”: “I miei disegni ispirano e non definiscono. Non determinano niente. Ci collocano, come la musica, nel mondo ambiguo dell’indeterminato. […]
Il senso del mistero è l’essere continuamente nell’equivoco, nei doppi e tripli aspetti, indizi di aspetti (immagini nelle immagini), forme in divenire o che si configurano a seconda dello stato d’animo di chi guarda. |…] Ho messo nelle mie opere una porta aperta sul mistero”. Beatrice Cignitti è certamente un’artista dell’immaginario ma mai dell’eccentrico o dell’eccessivo, perché resta ben radicata nella realtà tangibile. Costruisce il visibile scolpendo col segno nell’invisibile, dandogli un respiro e al contempo una plasticità vibrante. Compie un cammino solitario perché ha scelto la via della necessità interiore, proprio quella da cui la maggioranza della gente rifugge per inseguire lo stordimento narcisistico dei social e di una pervasiva retorica tecnologica. Per lei tutto è degno di attenzione ed ammirazione, ogni cosa ha il suo “daimon”, il suo bagliore segreto che la fa rifulgere se si sa vedere oltre le apparenze e le convenienze. Perché, in realtà, tutto sta nel nostro sguardo più che nelle cose in sé stesse, e quello di Beatrice, come si vede nell’ipnotico “Autoritratto a 55 anni”, è nutrito dall’anima, parte da molto lontano, da profondità abissali legate alla sensibilità, per attingere anche alla memoria, infine arrivando verso l’esterno e tutto trasfigurando con una sorta di respiro luminescente. Così la tecnica arriva ad identificarsi col sentimento. Il foglio di carta non è terreno di scontro per gestuali psicomachie né per fredde progettualità o aridi citazionismi ma si dispone come un nido, un ricettacolo accogliente per la fioritura di segni a grafite che danno un corpo auratico al mondo esterno riunificandolo e ridestandolo in una nuova unità che purifica e supera quella serie di discontinuità, di differenze, di conflitti con cui la realtà stessa si presenta. Si ha come l’impressione che un’energia centripeta raggrumi infiniti atomi dispersi nel caos dandogli un senso inedito e poetico, prima che si sparpaglino definitivamente finendo nell’oblio e nel nulla. Così Beatrice trova nelle apparenze del mondo un mistero gentile, accogliente, trepidante, mai minaccioso o apocalittico. Usando la sua matita come una bacchetta magica, la nostra artista rivela che tutto è prezioso, se si ha la ricchezza interiore per rendersene conto.
(1996)
 Beatrice Cignitti sta attraversando, direi con successo, una fase cruciale nella sua evoluzione di artista; si è bene inoltrata, cioè, sulla via del superamento dell’esperienza compiuta all’Accademia di Belle Arti di Roma (ed anche oltre) sotto la guida di un Maestro amatissimo e quanto mai assorbente quale Enzo Brunori, per precisare una propria originale voce, una propria genuina natura di pittore.
Beatrice Cignitti sta attraversando, direi con successo, una fase cruciale nella sua evoluzione di artista; si è bene inoltrata, cioè, sulla via del superamento dell’esperienza compiuta all’Accademia di Belle Arti di Roma (ed anche oltre) sotto la guida di un Maestro amatissimo e quanto mai assorbente quale Enzo Brunori, per precisare una propria originale voce, una propria genuina natura di pittore.
Ecco così riaddensarsi i nuclei figurativi che prima, in una felice ripresa di moduli “puntinisti”, si erano come dissolti nel turbine quasi astratto della cromia, ecco così riacquistare una fisionomia gli elementi vegetali e naturali (piante e fiori ma anche conchiglie e altri oggetti) che sono il felice pretesto della sua attuale pittura. Con questo processo di ridefinizione dell’immagine si viene a saldare la strana dicotomia tra la precedente pittura della Cignitti, stordita nell’ebbrezza panica del colore, e il suo disegno, sorgente da un nero di tenebra come un sottile fiato di luce, rigorosamente figurativo, “magico” in senso metafisico, esattamente, puntigliosamente definito e calibrato in ogni dettaglio eppure onirico e misterioso, con qualche parentela col disegno di Seurat e più ancora con quello di Redon.
Ma torniamo alla pittura, che al momento è quanto sembra preoccupare l’artista in modo pressocché esclusivo. Detto del rinsaldarsi delle immagini rappresentate in questi quadri e in queste tempere, rimane da osservare come il punto di riferimento culturale dell’artista – che prima era la pittura divisionista, insieme a quel modo di scomporre luci e sensazioni cromatiche tipico di Enzo Brunori – oggi sia in maniera abbastanza esplicita il “fauvisme” e soprattutto Matisse, con semplificazioni di forme estremamente sintetiche e “tagli” perentori di luce e di colore. Certo, sono quadri tutt’altro che drammatici, di un’eleganza raffinata da far pensare al primo Dufy, ma quadri fermamente concepiti e dipinti, con un’architettura essenziale e insieme fantasiosa,
A partire da questi risultati, così elegantemente risoluti e netti, non è difficile preconizzare alla Cignitti un cammino sempre più audacemente personale. L’esperienza scolastica è ormai ben lontana alle sue spalle, sicché non v’è che inoltrarsi sempre più decisamente nei territori perigliosi e frastornanti della militanza artistica. Hic sunt leones, lo sappiamo bene, ma la nostra giovane artista ha doti di cultura e capacità di mano in grado di farla felicemente sopravvivere.
(2001)
Jede Kunst basiert auf beherrschtem Handwerk, und das ist die Stärke Cignittis. Der Bleistift wird ihr zur verlängerten Hand. Mit ihm formt sie Blüten, Glas und Muscheln in zarte Strichlagen, dicht versponnen zu einem silbrigen Gewebe aus Licht und Körperschatten. Ein sanftes Mondlicht scheint die Dinge zu umfangen und ihnen magische Kräfte zu verleihen. Die kleinen Gebrauchsutensilien verlieren ihre Banalität zugunsten meditativer Reinheit. Ein Wasserglas, eine Weinflasche, ein belangloses Döschen – sie werden makellose Schönheit. Alpenveilchen und Sanseverien konservieren ihr Wachstum im Dornröschenschlaf des sie umgarnenden Strichgefüges <…>. ,,Notturni für Solo-Bleistift“ nannte der Kunstkritiker Marco Di Capua die Zeichnungen seiner Landsfrau. Ein treffender Vergleich für die Stillleben im Vollmondschein aus Grafitmine auf kostbarem Fabriano-Bütten.
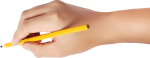
DISEGNI DI BEATRICE (2010)

Beatrice ricerca l’ombra, fa emergere da essa i caratteri intensamente personali della sua esperienza, la realtà esteriore è soltanto un punto di partenza, in nessun caso fine a se stessa. Scruta nella penombra della coscienza, porta in superficie il suo segreto e, dopo aver riprodotto accuratamente oggetti del mondo esteriore, cerca equivalenti alle proprie emozioni fra la tensione dell’oscurità e lo scoppio della luce.
Marcel Proust ne Il tempo ritrovato ha affermato che chi si contenta di descrivere le cose, dando di esse un semplice compendio di linee e di superfici, le impoverisce irrimediabilmente, interrompe ogni possibilità di elevare lo spirito nella regione del mistero. «Veri parassiti dell’oggetto coltivano l’arte in un ambito esclusivamente visivo, chiudendo a tutto ciò che sarebbe in grado di imprimere, anche nelle cose più modeste, la luce della spiritualità». E Odilon Redon, se da un lato incita a tenere gli occhi aperti sugli aspetti della realtà concreta, senza la quale ogni concezione resterebbe allo stato di astrazione, dall’altro apre all’immaginazione, all’imprevisto dei nostri sogni, senza i quali l’opera d’arte non avrebbe alcuno scopo.
Associando forze consce e inconsce, Beatrice allea espressioni plastiche singolarmente coerenti ad affascinanti moti di vita segreta. I suoi disegni si impongono per la certezza del tratto, la capacità di operare una metamorfosi del quotidiano attraverso immagini che emergono improvvise. Lo sguardo fissa le forme della natura e le spoglia, rivelandone l’ambiguità e l’artificio, sottraendole a ogni accidentalità. Presenze imperiose e sigillate sono connotate da un’elusività che allea gamme tonali e strutture grafiche legate a una realtà attentamente osservata a un mondo fantastico.
quotidiano attraverso immagini che emergono improvvise. Lo sguardo fissa le forme della natura e le spoglia, rivelandone l’ambiguità e l’artificio, sottraendole a ogni accidentalità. Presenze imperiose e sigillate sono connotate da un’elusività che allea gamme tonali e strutture grafiche legate a una realtà attentamente osservata a un mondo fantastico.
Sono disegni muti, misteriosi, dotati di un loro esoterismo, sorprendenti per intensità, esemplari di un lavoro casto e severo, che mira a compiere, con pazienza e tenacia, un’indagine in profondità, dove la forma non è nel tratto, ma all’interno di esso. Lavoro solitario, privo di corrispondenze dirette, animato da una disciplina volta a rincorrere una verità che appare protetta da un suo segreto. La scelta del disegno conferma la nobiltà di una tecnica esaltata da Ingres come «meraviglia dello spirito umano» e la predilezione per il nero – sorprendentemente definito da Renoir come «il più bello dei colori» – è la stessa che ha aiutato Redon a individuare la natura dell’invisibile.
Fogli ora lisci, ora scabri propongono immagini di conchiglie, di cardi puntuti, qualche vaso, bottiglie di matrice cézanniana, piccole ciotole, fogli accartocciati, foglie secche. Conchiglie dalle forme compatte e armoniose, felici in una perfetta, barocca rotondità, risultano talora corrusche nella ferocia di dentate mostruosità. Una di esse, fra le più belle, è dedicata a Osip Mandel’štam, il grande poeta e dantista russo, vittima della rivoluzione, che in una sua lirica paragona sé e la sua sofferenza a «una conchiglia senza perle» gettata nella voragine dell’universo. Una sintesi poetica di rara efficacia si individua ne La cena (2006), disegno che evoca con depurata semplicità e riflessi cangianti l’episodio evangelico. E, a concludere l’arco di un rapporto con una natura ricca di significati traslati, è il brillio drammatico della Corona di spine (2006), sigillo sintetico ed emblematico di una straordinaria avventura di dolore e di amore. Emile Zola ha sostenuto che l’arte può essere considerata come «esperienza della vita filtrata attraverso un temperamento». E l’arte di Beatrice denota un acuto senso di introspezione, testimoniato anche da quell’occhio che nell’Autoritratto a 40 anni (2006) sembra scrutare il mondo ma, soprattutto, scruta se stessa.
PER BEATRICE (2023)

Nel suo recente lavoro, l’artista si rapporta con inedita tensione ad alcune opere di Auguste Rodin e alla pietà Rondanini di Michelangelo. Complessa esperienza che lascia una traccia profonda sia nella conquista di valori volumetrici riferiti a Rodin, sia in una più radicale sottrazione nei confronti dello smisurato grumo di amore e dolore insito nell’estremo capolavoro michelangiolesco. “Esattamente questa è diventata, con il tempo, la mia esperienza disegnativa: da un approccio più analitico e dettagliato, negli anni della mia giovinezza, sono gradualmente giunta ad una visione sempre più “scultorea” dell’immagine, attraversata e definita dalla luce e dall’ombra”, ella afferma. Eleva la sua attività basandosi su principi fondanti quali la rodiniana nozione di “estetica delle rovine” e il fascino del volume scultoreo trasmesso nell’esortazione agli artisti e formulato nel testamento di Rodin.
Il mito è riattualizzato in funzione di una lettura contemporanea di storie relative a figure come Danaide, Faunessa, Centauressa e Cariatide con urna, tutte realizzate dal 2016 al 2021.
Sola e stremata nell’oscurità degli Inferi la Danaide di Rodin è condannata a riempire eternamente d’acqua un’incolmabile botte forata. Lo scroscio impetuoso proveniente dall’anfora si mescola alla grande massa dei capelli, quasi ad anticipare la sorte finale della trasmutazione della creatura in acqua. Per Beatrice il nero è elemento generatore, l’immagine pur iscritta nell’oscurità di una dimensione atemporale, perde ogni aspetto tragico, esclude il supplizio, assomma le forme ed elude lo spasmo espresso da un volto angosciato. Gli elementi rodiniani sono sintetizzati, non si adotta la ferocia né la disperazione di fronte ad un esito definitivo. Istituendo un paragone, nell’uno il blocco di marmo funge da strumento che assume tutte le esigenze di una drammatica corporeità, nell’altro interviene la morbidezza di un’assunzione più generosamente pietosa. Un più netto ricordo del marmo rodiniano è presente nella figura della Faunessa, anche se la frontalità è sostituita da una visione dorsale duttilmente articolata, seppure consistente, secondo l’esigenza di un disegno dotato di rotondità vagamente plastiche ed elevate levità. L’astanza del bronzo è addolcita dal ricorso ad una rapsodica penetrazione della luce che batte in alcuni punti e cede in altri al mistero.
Nella Centauressa, mirabile scultura in diretto rapporto con la poesia dantesca, Rodin evidenzia il confronto fra corpo e anima nella trasformazione dell’immagine di un cavallo in giovane donna. La fantasiosità dell’insieme è echeggiata nel disegno, attraverso una rapida summa di passaggi fondamentali come sempre assorbiti ma arricchiti dalla presenza di un nero che penetra con aerea levità. Ogni rappresentazione del corpo è trascurata e lo slancio dell’anima è assunto come segnale del simbolico dominio di un’energia di matrice spirituale. Nato dall’ombra, il disegno ripercorre l’audacia del gesto che lascia emergere dal corpo del cavallo le membra femminili lanciate verso l’alto in un respiro largo e appagante. Squarci misteriosi solcano le estremità dell’opera formando piani che sembrano spostarsi liberamente nello spazio.
Rodin mostra una Cariatide accovacciata che sostiene il peso fisico e morale di un’urna, resa nella Cariatide con urna di Beatrice quasi elemento etereo, impalpabile, mentre al corpo sono restituite rotondità e solidità volumetriche.
Nel disegno dedicato alla Pietà Rondanini di Michelangelo, si rileva un’estrema sublimazione dell’incontro di amore e dolore in un abbraccio che sembra ridurre i due corpi ad una inscindibile disperata unità. Beatrice avverte la necessità di una penetrazione rapsodica, indizio di un’urgenza creativa continuamente messa in gioco di fronte alla totalità di un capolavoro, pochi tratti possono renderla. Scultura estrema come estremo è il gesto che ne riproduce alcuni elementi: il frammento di un drappeggio, il volto dolente della Vergine, un indistinguibile volto del Cristo e il segnale di una mano ad indicare la totalità di un abbraccio. Il capolavoro pretende il rispetto di un’assoluta integrità, chi guarda può soltanto essere illuminato da pochi spezzoni colti da un’immagine eterna.
In una dimensione di estrema riduzione ma anche di intensa concentrazione è l’Autoritratto a 55 anni. Summa che non smentisce il gusto di una rivendicazione di autonomia e di energia vitale. Gli occhi perlustrano ciò che ci circonda e l’intorno è valorizzato dalla penetrazione dello sguardo. La vita è nelle cose che amiamo e che rappresentiamo come oggetti della nostra quotidianità in una dimensione libera e felice. Beatrice guarda ma non si perita di dare allo sguardo il valore di un gesto alto, riflesso di una coscienza che sia sostanza di verità.
A testimonianza della presenza simbolica del quotidiano citiamo un succoso Melograno giunto attraverso lo schermo del computer, simbolo di un’appagante ricchezza della natura, portatrice di piccole gioie sorgenti di serenità e umanità degli affetti. Siamo passati dalla sfida di un rapporto con i grandi valori, ad oggetti del nostro esistere, anch’essi dotati di significati profondi.
Ciò testimonia felicemente della necessità creativa e della fresca inventiva nel prezioso mondo onirico di Beatrice.
LA LUCE DELLA NOTTE (2001)

La manifestazione folgorante di una luce che nasce dal buio colma il pensiero compositivo dell’opera di Beatrice Cignitti. Come se, nottetempo, ella avesse avuto un contatto visivo con il sogno della sua pittura, il nero delle matite su carta si rende veicolo di una luce che in condizioni diverse sarebbe stato difficile immaginare.
La poesia di Beatrice Cignitti è quella dei silenzi delle cose immobili; cose semplici, tanto semplici, che, però, nello sfarzo dei giochi chiaroscurali si colmano di mistero, divengono elementi di un formulario magico, acquistano un’identità altra da quella delle proprie origini.
Nel solco di una tradizione italiana, che da Morandi arriva sino a Ferroni, Beatrice Cignitti aggiunge all’ambito delle vite silenti, nei suoi disegni alteri, il senso di una provenienza da un’altra dimensione, da un altrove che è proprio del mondo delle idee. Delle idee ossessive che necessitano di una continua ripresa di attenzione, nella  diversità della collocazione e delle combinazioni, per ottenere il raggiungimento della reale comprensione della loro forma e composizione materica. L’occhio di Cignitti è un occhio di assoluto pittorico: al vero pittore interessa sempre e principalmente la luce. E, aggiungerei, l’ombra che ne deriva. Per lui le cose sono quello che sono e acquistano importanza e valore solo a fronte della loro posizione rispetto a una fonte luminosa.
diversità della collocazione e delle combinazioni, per ottenere il raggiungimento della reale comprensione della loro forma e composizione materica. L’occhio di Cignitti è un occhio di assoluto pittorico: al vero pittore interessa sempre e principalmente la luce. E, aggiungerei, l’ombra che ne deriva. Per lui le cose sono quello che sono e acquistano importanza e valore solo a fronte della loro posizione rispetto a una fonte luminosa.
Ecco, quindi, che inevitabilmente la scelta narrativa tende al riduzionismo. Pochi elementi in campo, pochi oggetti su cui l’osservazione metodica e assoluta dell’occhio di Cignitti eleva a potenza l’ossessione di uno scavo in profondità, in quella che potrebbe essere la “psicologia dell’oggetto”. Una bottiglia, dunque, una conchiglia, tradizionalmente, e poi una ceramica berbera, una aggiunta “esotica”, lievemente straniante la messa in scena degli elementi. In questo contesto di riduzione, Beatrice Cignitti mette alla prova e potenzia la capacità naturale del suo sguardo di creare sospensione, un continuo stato di attesa che non sapresti dire da cosa possa specificamente nascere, ma che avverti come uno stato d’animo inevitabile. Sarà lo scavo nel buio e nel nero di una grafite che esibisce frottage, tessitura da incisore che vede il mondo attraversato dall’intreccio dei segni stabiliti dal proprio strumento; sarà che ti domandi il reale luogo di provenienza della luce, la fonte non facilmente individuabile; o anche l’emissione dell’aura posseduta dagli oggetti stessi, e che nei disegni a matite colorate appare d’improvviso, flagrante… Ma ti sembra di immediata comprensione che non ci si può, non ci si deve arrestare a ciò che appare. Come se gli oggetti delle sue nature morte stessero lì a simboleggiare altro da sé, a darsi per metafora, a indicare che ogni cosa a questo mondo è riflesso di ben altro, che spesso ci vergogniamo di nominare, ma che è sicuramente, e se non altro, il principio creativo.
Ecco, dunque, un nodo complesso a raccontarsi, a interpretarsi. Da dove proviene la luce dei disegni di Beatrice? Più si guardano e più si è incerti a definirne l’origine; fino al punto in cui non si può più fingere con se stessi e si è costretti ad ammettere che quella luce è come lo sguardo divino che permea di vita, rendendola possibile al concepimento. Vita che genera, dunque: vita silente, pertanto, non natura morta.
Tutto questo con poco, come si è visto. Eppure il segreto è tutto qui: scoprire che la semplicità è già un raggiungimento importante, perché essere semplici non è facile. E Beatrice Cignitti, per sua umana natura, sembra riuscirci per naturale predisposizione.
OMBRE (1997)

Un visitatore attento e discreto distinguerebbe, forse, per primo il volto di Beatrice Cignitti, abilmente fissato sulla carta attraverso le modulazioni ed i passaggi del nero, agitato dagli splendori perlacei di una matita che compete con le acide nerezze delle morsure d’acquaforte.
Il viso dell’artista, quasi separato dal corpo nascosto nell’ombra, sorge come un astro velato nel cielo notturno, attraverso un addensamento di tenebre profondissime, e s’impone al centro dello spazio come il motore immobile di un universo privo di luce.
Quel volto offuscato dal tratteggio che vi si depone come una fitta e lieve cortina, è una delle rare presenze umane nelle opere dell’artista, nature morte in cui compaiono abitualmente conchiglie e vasi, piante e fiori. La pittura di Beatrice Cignitti è fatta di stesure cromatiche leggere, dominate da una luminosità intensa, in cui i colori sembrano divorare il chiaroscuro anche nelle tonalità più fredde e nelle  campiture più cupe.
campiture più cupe.
Il disegno invece, come ha già notato Guido Giuffré in suo scritto dedicato a Cignitti, appare quasi come una seconda personalità dell’artista. Le sue opere grafiche, realizzate con una tecnica abile e sperimentata, sono basate su una profonda stratificazione di segni, su una meditata complessità di tratteggio.
Nei suoi fogli saturi di grafite, coperti da un abbraccio oscuro, imprigionati tra intangibili pareti d’ombra, gli oggetti assumono una presenza diversa, una nuova centralità, misteriosamente slegate dalla percezione consueta delle cose.
I rami dei pothos e dei ciclamini si allungano e s’intersecano, definendo angolazioni inquietanti e geometrie straniate, le foglie si distendono e s’incrociano nello spazio, costruendo rigorose architetture di vegetazioni, le piante si sollevano, diradando il nero assoluto da cui sembrano avere origine.
I riflessi argentei e impalpabili delle conchiglie e dei vetri attraversano e agitano le ombre, sottili fili di luce baluginano dagli oggetti come bagliori lontani che attraversano la notte.
Tuttavia, tra i disegni immersi nelle tenebre di Beatrice Cignitti, la Natura morta con ceramica berbera (1997) sembra evocare un nuovo percorso.
In quest’opera si compie una felice unione tra disegno e pittura, realizzata grazie alle matite colorate, con cui l’artista può fondere la ricchezza cromatica alla saldezza del tratto, un connubio che può ricordare l’alchimistica congiunzione degli opposti, tra la maschile secchezza del disegno e la femminile fluidità della pittura.
Il nero risplende con riverberi di pietre preziose, un cromatismo più vivo s’infittisce tra le ombre rendendo più penetrante la definizione degli oggetti che prendono possesso dello spazio con una rinnovata stereometria. Similmente alla fase dell’opus alchemico dove i colori della coda del pavone sacro a Giunone annunciano la fine dell’oscurità della nigredo, il colore, come risorto dopo la discesa agli inferi, si fa strada tra le tenebre, con bagliori di alba boreale e annuncia una luce trasfigurata da una nuova intensità.
NOTTURNI PER MATITA SOLA (2000)

Il «posto primordiale» che anni fa, in modo memorabile. Jean Clair riassegnava al disegno, la stessa perorazione per un suo ritorno, era traccia – dopo gli anni Sessanta e Settanta e quella loro creativissima incuria che nel puro gesto di disegnare aveva visto solo inanità e obsolescenza -di una possibile rifondazione del linguaggio figurativo. e di una sua precedenza assoluta, immemoriale, rispetto alla pittura. «Colui che disegna – scriveva Clair – nutre il progetto di abolire la distanza fra se stesso e la realtà. E un passaggio. Esso appare o riappare ogni volta che l’arte si trova in un vicolo cieco o in un’impossibilità. Di qui l’nnocenza fondamentale di colui che oggi fa il progetto di disegnare. Posto davanti al mondo come se questo avesse ancora qualcosa da dirgli, e liberato dallo scetticismo dei suoi contemporanei, egli è di nuovo Tessere nudo e primitivo all’alba della civiltà. Tutto comincia con il disegno, e con esso tutto può ricominciare».
Quando Beatrice Cignitti esegue queste sue carte, così limpidamente inattuali e di una maniera che è senza difetti, compie il doppio esercizio della contemplazione e della difficoltà. Esercizio che apparirà scandaloso ai dannati della produzione e dell’accumulo e a confronto di tutta l’enorme quantità di sottoarte che li specchia, specie di creatività obbligatoria, di genere inferiore, senza approdo, senza castone. (E sembrerà eccessivo o superfluo ricordare come oggi la fotografia, e i suoi derivati dappertutto, sono rivolti sempre, in qualche modo, sul lato della morte, mentre quelle che Gino De Dominicis chiamava arti maggiori – del disegno, della pittura, della scultura – corrispondono a prove di vita, di durata?) Con quali pazienza e lentezza ed esattezza Beatrice sa estrarre ogni effetto possibile da un mezzo così semplice e povero. E non per esibire vanamente non so che bravura o destrezza – anche se poi il talento qui è evidente, e riflette l’immagine di una bambina che fin da subito si esprime bene, facilmente, solo così – ma perché esistere, per questo tipo di artisti, è tentare di svelare l’essenza dell’altro, e poco importa che questo sia una persona, una parte di mondo o soltanto un oggetto. Aggiungo che la materia utilizzata, il mezzo, come ognun sa, non è mai neutrale ma dice la sua, attingendo a chissà quali fondi segreti, Vedo che a questo proposito Cesare Vivaldi, presentando il  lavoro di Beatrice, faceva i nomi di sommi disegnatori come Seurat e Radon, giustamente, solo che il primo sappiamo quanto stralunasse il soggetto prendendone le distanze per troppo amore formale, mentre il secondo, dirigendosi in una direzione inversa, si immergeva nel buio della materia traendone vita fantastica e parecchi sogni. Beatrice è come se abbia deciso di abitare una striscia di terra più sicura, concreta, decisa a non perdersi nell’invisibile. Riprende storie già periodicamente narrate dal mondo dell’arte: storie di ripari cercati, desiderati, di spazi protetti, in disparte da tutto.
lavoro di Beatrice, faceva i nomi di sommi disegnatori come Seurat e Radon, giustamente, solo che il primo sappiamo quanto stralunasse il soggetto prendendone le distanze per troppo amore formale, mentre il secondo, dirigendosi in una direzione inversa, si immergeva nel buio della materia traendone vita fantastica e parecchi sogni. Beatrice è come se abbia deciso di abitare una striscia di terra più sicura, concreta, decisa a non perdersi nell’invisibile. Riprende storie già periodicamente narrate dal mondo dell’arte: storie di ripari cercati, desiderati, di spazi protetti, in disparte da tutto.
Difficilmente certe polarità del disegno risultano più evidenti come in questo caso: essenzialità e concentrazione, una forza che seleziona e traccia contorni anche là dove non ce ne sarebbero (perché è così che noi strappiamo all’opacità, all’inerzia ciò che vediamo) che percepisce ritmi di linee anche solo mentalmente, che isola e focalizza le immagini (la continuità del mondo, muta, assediante, è spezzata, pochi elementi sono eletti) e ne riconosce e tenta con la pressione della mano i limiti, i punti di fuga nello spazio, che antepone al caos il nitore mansueto di alcune cose, la loro parte di luce, l’ombra. Limpidamente, con chiarezza.
Solo che qui è sempre sera. Diresti: notturni per matita sola. Un piano di posa un po’ lunare, simile a un paesaggio vuoto, dove siano deposte lucide, stravaganti architetture. Una luce scura. E un’ombra – ombra che è sentimento del tempo, concorderebbe Redon – che scintilla. Poiché ricomporre su di un altro piano gli oggetti – ciò è arte – equivale a rappresentare e a immaginare, dichiarandoci fedeli alla realtà proprio nell’attimo in cui ne fuggiamo. «L’oggetto – ha scritto sulla Cignitti Guido Giuffré – resta del tutto assorbito dagli elementi della forma – essenzialmente la luce e l’ombra – che insieme lo determinano e lo trasfigurano; esso rinasce come purificato, in perfetta equidistanza tra la realtà della natura e quella dell’emozione».
Ecco allora vetri e conchiglie e ceramiche – ma perché sempre contenitori vuoti? offerte votive? in attesa? nascondigli e raccoglitori di che? – figure che si lasciano lentamente plasmare dallo spazio che le circonda, come stando in un grembo chiaroscuro. E poi rifrazioni interne della materia, sostanze mutevoli, echi, specchiature: quasi che ogni singola immagine possegga non una ma molte voci, variabili, modulate. Suoni che, non percepiti, rigano l’aria. E quando ci sono apparizioni di colori, nei lavori di Beatrice, li vede molto efficacemente Lorenzo Canova, come risorti dal buio» un’invasionee “con bagliori di alba boreale”
C’è da tremare per tanta mitezza e volontà di non cedere al disincanto. Oggi che tutto depone contro destini così. Per questo vorrei dire a Beatrice di sacrificare ancora molto, di proteggere il grado di ascesi di questi suoi disegni aprendoli su più ampi strati psicologici, di sentire vicina a sé, per esempio, l’azione profonda svolta da un artista come Gianfranco Ferroni, di essere insomma ancora più raccolta su se stessa, di sorvegliarsi quasi con cattiveria, simultaneamente assumendo davanti agli altri il piacere – e il tono – del distacco.
“ACCADEMIA 50 – GENERAZIONI TRASFORMAZIONI ATTRAVERSAMENTI”
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE
MACA PALAZZO TIRAVANTI 16 FEBBRAIO 24 APRILE 2024
 Le opere di Beatrice Cignitti sono un omaggio alla tecnica tradizionale del disegno, punto di origine delle arti visive e strumento indispensabile di riflessione e di indagine.
Le opere di Beatrice Cignitti sono un omaggio alla tecnica tradizionale del disegno, punto di origine delle arti visive e strumento indispensabile di riflessione e di indagine.
La poetica di questa artista si nutre di metodi secolari e gesti rituali; affida l’interpretazione del reale a tratti metodici e scanditi, volti a esplorare i volumi e a farli emergere ben prima dei profili. Corpi e nature morte sono osservati nella loro natura plastica messa in evidenza da un disegno marcatamente pittorico, in cui le forme sono definite per contrasto costruttivo e per contrapposizione dialettica di luce e di ombre. Da un fondo di tenebra, i corpi e gli oggetti di Cignitti affiorano in qualità di presenze luminose, masse evocative a rilievo in cui la luce si rapprende in zone ad alta luminosità fino ad operare una trasfigurazione della materia e una sua declinazione simbolica.
“Faunessa”, opera ispirata ai lavori del grande maestro francese Auguste Rodin, termine di confronto e dialogo per l’artista, e “Melograno”, esempio delle nature morte che compongono il repertorio disegnativo di Cignitti, ci avvisano della costante imperturbabilità della tradizione e ci portano a contatto con il valore trasformativo della luce, capace di trasportare in dimensioni illusorie e visionarie anche le forme apparentemente più ancorate al reale.
LE OMBRE METICOLOSE DELLA MATITA DI CIGNITTI (1997)

Beatrice Cignitti espone alla Galleria Lazzari (via di San Giacomo 22) opere titolate «Ombre». Le opere tutte realizzate a matita su carta meticolose e rare, raccontano del segno insistente sulla carta, descrivono i volumi per ombre degli oggetti in natura quando silenziosamente rapiscono lo sguardo della grafite. Calle, grande pothos, ficus, ciclamini rosso-rosa, fiori e piante catturate dall’ondeggiare del chiaroscuro sul piano del foglio, colme di rarefatta passione troneggiano alle pareti contornate da un passepartout che le stringe d’assedio: al colmo della perfezione Cignitti usa carte Fabriano F6, rare e preziose senza acidi.
Il grigio scuro della grafite ottenuto dai continui picchiettamenti della punta della matita, sempre e comunque appuntita al punto giusto, è inquieto e si ridesta compagno sodale accanto ai grigi fino al bianco della carta in rapidi guizzi di silenziose ombre. Appunto come il titolo che riecheggia lontani misteri teatrali, un silenzio assoluto, il piacere di sentire la grana della carta che assume su di sé il frastuono della composizione.
Pittrice più unica che rara Cignitti è stata allieva in tempi fulgidi per il segno e il colore di Enzo Brunori il quale sapeva fare il «maestro» e si prodigava fino alto «sgolamento» del pigmento sui valori dei toni e dei semitoni; primi piani e taglio della prospettiva cromatica. Cignitti è stata una delle allieve più interessanti e a distanza di anni lo conferma come autonoma pittrice originale di indubbio valore artistico.
Al di là del fracasso pittorico circostante, Cignitti con il giusto silenzio continua a lavorare sui valori del chiaroscuro che prende forma; nell’apparizione dell’oggetto ritratto: pianta, fiore, vaso, barattolo che sia, Cignitti inappagata continua a lavorare nella convinzione che quel che conta in arte è la «perfezione imperfetta». Le luci cambiano, le prospettive si allargano con la luce del sole e poi quella artificiale tradisce le attese: insomma come per i grandi artisti, anche per Cignitti la luce è vita per l’opera d’arte, nel suo evolversi nello spazio. Ma è nei suo accanirsi nell’opera su carta che l’artista rapisce l’evolversi della luce.
(1996)

Che Beatrice Cignitti abbia studiato con Enzo Brunori si capisce bene. Brunori, per il quale Beatrice aveva ed ha mantenuto quasi un culto, oltre ad essere il pittore che sappiamo (maggiore della sua fama) era eccellente didatta, e non ultimo suo merito era il rispetto della personalità dell’allievo. Al primo punto dell’insegnamento egli poneva l’importanza della pittura come tale, alla quale si può dedicare la vita, com’egli stesso faceva, ma di cui non si può offendere la dignità. Beatrice ha inteso bene questa lezione; e non questa soltanto.
Qualche anno fa ella impiegava un raffinato puntinismo, elaborato, calibrato, derivato certo dalla conoscenza dei precedenti storici ma soprattutto dalla propria personale sensibilità. Brunori com’è noto centellinava le infinite sfaccettature della cromia traendone quelle magie – sull’eco fantastica e poetica della natura – che ne hanno fatto un maestro. La nostra giovane artista reinventava quelle modulazioni del colore riducendole, o concentrandole, nel puntinato, o magari in certe svirgolature orchestrate – valga anche il risvolto musicale – in vere e proprie scale cromatiche. La piccola tempera di un autoritratto del ’90 (l’artista era giovanissima) riassume nella sua grazia sottile quanta malinconia (e incanto, e amore per il colore e la luce) animava allora ed ha continuato ad animare il suo lavoro.
Ma il puntinismo, sia pure rivissuto, richiamava inevitabili parentele, italiane e straniere, difficili da riproporre; e Beatrice da qualche tempo esercita le variazioni del colore in più larghe campiture, traendo a spunto motivi vegetali: tralci e foglie come pretesto per impaginazioni astratto-decorative. Nelle quali tuttavia non di rado (e sono le intenzioni più segrete e più vive) sul ritmo della forma prevale il guizzo della luce, la gola d’ombra, l’intrico di un tralcio che accende più che carezzare il colore.
Ma la pittura – terreno fertile che Beatrice dissoda e che darà frutti copiosi – pure non è ancora suo terreno d’elezione. Il luogo privilegiato è il più lontano dall’insegnamento (ma non dalla personalità) del maestro: un disegno di forti accentuazioni d’ombra e di luci vuoi appena baluginanti, vuoi nette e corrusche. Così, come avviene talora, la personalità mite e dolcissima della giovane artista trova il suo momento più acuto, e forte, e complesso, in una dimensione cupamente notturna. Brunori aveva coltivato codesto versante; soprattutto in certe incisioni – parte non secondaria del suo lavoro – protagonista era proprio il modulato rapporto luce-ombra. Ma se, nella pittura, Beatrice trova se stessa nell’eco ancora operante del maestro, i suoi disegni, dove la visione è già matura, non vengono che dal raccoglimento, e dalla tenacia, capacità di ascolto e di riflessione, e infine dimensione poetica sua propria. Con la grafite Beatrice raggiunge una densità e si direbbe una perfezione ammirevoli. L’oggetto resta del tutto assorbito dagli elementi della forma – essenzialmente la luce e l’ombra – che insieme lo determinano e lo trasfigurano; esso rinasce come purificato, in perfetta equidistanza tra la realtà della natura e quella dell’emozione; la realtà appunto trasfigurata dell’arte. La conchiglia, l’uovo, la mela, i fiori, il vaso di vetro, vivono nell’evocazione della luce che intreccia sulle superfici vicende innumerevoli, apre gole fosche, spalanca abissi, o trae imponderabili luminescenze che crescono, dilagano, esplodono in abbagli di folgori taglienti. Lo spazio non è ribalta che si ritrae lasciando campeggiare l’oggetto, né questo è personaggio che subordina a sé quanto lo circonda. L’uno non vive senza l’altro, che ne accoglie e ne protegge il respiro, gli echi, le ansie. Come gli specchi in certi quadri fiamminghi, l’oscurità che circonda queste reliquie nasconde e rivela presenze segrete; ma soprattutto sensi riposti, attese, silenzi. In questi silenzi e attese, nella magica sospensione di ogni voce o suono dell’oggi, l’oggi ritorna anch’esso trasfigurato: fatto pensiero e incantamento. Il messaggio di Beatrice Cignitti ci giunge – nel tempo che stiamo vivendo – quanto più desueto, tanto più prezioso; come preziosi e rari sono questi disegni: per la parola che pronunziano e per il suo suono ineffabile.
BEATRICE CIGNITTI METTE IN MOSTRA IL SUO MONDO IN BIANCO E NERO (2010)

Bianco e nero. Come nei film e nelle foto che oggi fan quasi archeologia. E’così che Beatrice Cignitti, giovane artista romana preferisce raffigurare il mondo che la circonda isolandone in bianco e nero le forme. Ed è così che ha deciso di ripresentarsi nella mostra che fino al 31 gennaio tiene cartello nella Galleria Andrè di via Giulia 175. Una fede incrollabile nel primato del disegno, come strumento per afferrare il visibile e l’invisibile. E un gusto controcorrente di imporre il silenzio del segno, la chiave ambigua del chiaroscuro, inseguire i capricci della luce, ritagliando lo spazio con la matita. L’effetto delle opere incluse in questa personale, presentata in catalogo da uno smagliante saggio di Maria Teresa Benedetti è sorprendente. Conchiglie, vasi, bicchieri, piccole ciotole, fiori e foglie secche: un campionario di nature morte in posa su drappi bianchi che con tratto sicuro l’autrice increspa in un moto ondoso secco e incalzante. Cimeli che la magia del bianco e nero, nitido e terso come un gioco di specchi, trasforma in misteriosi miraggi, carichi di intensità, perchè la visione prende vita da un singolare accumulo di realtà e irrealta: gli oggetti ci appaiono fermi, congelati in un tempo fuori del tempo ma sembrano vibrare sotto la superficie un respiro d’altrove a volte intimo come una confessione sottovoce a volte persino minaccioso e inquietante come una profezia.
L’ARTE DEL BUIO (2023)

Una bella mostra curata da Gabriele Simongini rende omaggio a Beatrice Cignitti, artista appartata che ha scelto il buio e il mondo delle ombre come suo terreno di ricerca. Ma sempre restando aderente alla trasfigurazione della classicità
Con caparbia coerenza, da quando ha deciso di scommettere sulla sua vocazione per l’arte e costruirci su la sua vita e la sua carriera, Beatrice Cignitti governa un regno di ombre. Lì ha eletto il suo rifugio, il suo laboratorio e il suo palcoscenico. Scelta in controtendenza, almeno per l’Occidente di oggi, così estraneo al pudore fecondo della semioscurità esaltato da un custode della tradizione giapponese, come lo scrittore Tanizaki. Un Occidente che sul culto artificiale della luce ha fondato i suoi traguardi di modernità creativa, misurando e inseguendo i progressi e lo spettacolo della tecnologia: dall’accensione dei lampioni a quella degli specchi luminosi del cinema, della tv, dei computer.
Quand’era poco più che ventenne, Beatrice Cignitti ha trovato invece nel buio la sua cifra espressiva e il suo luogo di pittrice. Restringendo sempre più al bianco e nero la sua tavolozza, il mistero della cromia condensato dalla presenza e dall’assenza fantasmatica di tutti i colori. Rinunciando al pennello per la matita, all’intensità onnivora della campitura dipinta per una ragnatela di segni sovrapposti e intrecciati, così fragile che basta un errore a dissolverla. Un lavoro di concentrazione e devozione monastica, mesi interi per raggiungere sul foglio una meta compiuta. E vedersela insieme sfuggire davanti, come succede ad ogni artista che insegue la sua verità dando la caccia all’invisibile. Oltre il confine muto della pura apparenza. Per spingersi verso quell’altrove, certo, poi servono anche dei trucchi. Il ricorso alla bicromia del chiaroscuro non basta. Per mettersi in scena attraverso forme e volumi se l’autore, come ha fatto la Cignitti, rinuncia al monologo microfono in mano, bisogna scegliere i propri attori e addestrarli. Il suo cast l’autrice lo ha composto servendosi di oggetti che la circondavano. Vasi, fiori, recipienti, bottiglie, matasse di fili, giocattoli. Il sexappeal quotidiano dell’oltreumano. All’inizio un ingaggio di comparse. Poi cimeli recitanti più estroversi e smagati, arruolati e collaudati in altri contesti, che sulla battuta trascinano il peso di esperienze, richiami di vissuto e immaginario diversi. Come le conchiglie, modellate dal respiro del mare, dal setaccio della sabbia e dell’onda in giochi di trasmutazioni infinite. Uno dei suoi leit motiv più riusciti.
Il secondo passaggio è stato quello di togliere loro e ai loro corpi l’ingessatura da nature morte. E qui è arrivato il colpo d’ala: la manipolazione della luce. Gli oggetti che Beatrice Cignitti ritrae e ha continuato a ritrarre, sfuggendo a ogni regola fisica, non si limitano ad assorbire la luce, ma la emettono a segnare e invadere di stupore lo spazio. Insomma si accendono e ti brillano davanti come filamenti di lampadine. Autorizzando lo spettatore ad ogni fuga di coinvolgimento e di fantasia. Ricordi che si ridestano, emozioni, contrappunti di musica. L’aura, un risarcimento dell’aura data da troppi per morta, che torna a impregnare di mistero e profondità, come un timbro di autenticità, l’unicità dell’opera d’arte.
Il bagliore segreto della realtà, battezza con grande acume questa tensione estetica Gabriele Simongini, critico e storico d’arte che ha accompagnato per anni il decollo e le rare, applaudite, apparizioni pubbliche di Beatrice. E ha impresso come chiave di lettura questo titolo alla mostra con cui questa autrice si ripresenta al pubblico nella piccola sala bomboniera della galleria Monogramma di via Margutta, a Roma. Per dar conto di una svolta esistenziale e creativa che sta trasformando il suo regno di ombre. Infrangendo quella cappa di solitudine che la convivenza con un universo di soli oggetti si trascina appresso. E popolando di personaggi e presenze quell’universo parallelo e transumano di riflessi emotivi e mediati nel quale si era confinata., senza mutare, almeno in apparenza, la sua tecnica e il suo stile. Come? Chiamando in scena i corpi forgiati da alcuni maestri del passato che da sempre l’hanno ispirata.
Leggendo la sua biografia si intuisce che quel salto d’ispirazione è maturato quattro anni fa, quando da allieva Beatrice Cignitti si è trasformata in docente, prima partecipando come insegnante di disegno dal vivo ai corsi della scuola di nudo dell’Accademia di Roma, purtroppo inspiegabilmente cancellati dalla nuova dirigenza, poi ottenendo una cattedra all’Accademia di Frosinone. Un’esperienza brutalmente interrotta e un nuovo compito di trasmissione di strumenti e saperi che ha svincolato e cambiato anche i suoi orizzonti d’artista. Facendo emergere un nuovo impellente bisogno, quello di impadronirsi ancor più dello spazio del foglio e incanalare il disegno verso il modellato della scultura, l’urgenza più tattile delle emozioni che il corpo umano sprigiona. E che solo il genio, la mano degli artisti più dotati sa strappare all’inerzia della pietra, del marmo. Della morbidezza inorganica della creta.
E chi più dotato dei due maestri, Rodin e Michelangelo, che in questo primo esperimento sul suo nuovo corso Beatrice ha chiamato in scena, usando, mettendo in posa e reinterpretando come modelli alcuni dei loro capolavori.
Una fase di rodaggio dichiarata come tale dalla decisione di affiancare a questi studi su icone da museo, cui è riservata più di metà della mostra, una sorta di riepilogo dei lavori precedenti affidato a una decina tra lavori mai esposti, o opere inedite realizzate di recente che continuano invece a declinare l’ingannevole spartito di “nature morte”. C’è persino una fantasmagoria di pastelli colorati, pratica in cui la Cignitti si è cimentata e poi ha lasciato in disparte.
Il primo e il dopo a confronto insomma. Inevitabile, a mio avviso, che la bilancia penda su questo secondo più praticato versante, reso più intenso da un lungo lavoro di perfezionamento e di scavo che scavalca le rigide briglie delle intenzioni, della razionalità dell’impianto, della ricerca di perfezione e consente alla pittura di dipingersi e spingersi da sola verso la soglia imprevedibile, sconosciuta del senso e del non senso del vivere. Chi ha detto che gli oggetti siano corpi più silenziosi ed inerti, abbiano meno cose da raccontare e da dire, quando l’arte li sottrae al loro destino di cose, violando le rigide gerarchie dell’uso e della convenienza che stanno precipitando verso il baratro il destino dell’umano? Che le architetture, le piazze deserte e metafisiche di De Chirico, che le bottiglie di Morandi rimandino voci più deboli, di un nudo e di un ritratto?
Sfidare i grandi del passato, confortati anche dalla sintonia con le idee che hanno espresso, comporta un rischio da soppesare: quello di restare schiavi dell’incanto per cui li ammiri, dell’ebrezza dell’aura che avvolge i loro capolavori e dimenticare, trascurare quella che tenti – che artista saresti se no… – di recuperare per altre strade con le tue reinterpretazioni. È questo pericolo che credo volessero sventare le avanguardie che più volte hanno profetizzato, invocato la morte delle Accademie. Per questo trovo formalmente impeccabile ma freddo, ammorbidito da un eccesso di devozione, l’omaggio che Beatrice Cignitti rende qui in mostra alla Pietà di Michelangelo. Troppo aggraziata, stemperata d’asprezza la torsione dei nudi che la sua matita prende in prestito alla Cariatide e alla Faunessa di Rodin. Molto più riuscito invece il movimento che restituisce a un altro capolavoro dello stesso autore, la Centauressa, facendo apparire e scomparire il miracolo di quella trasmutazione da donna ad animale, tra le quinte di un teatrino in penombra, in quella foschia di vellutato, capriccioso riserbo che è diventata col tempo la sua inconfondibile cifra d’artista e di donna, che si confessa e si nega, si fa avanti e si tira indietro allo stesso tempo, accetta di fare spettacolo ma non si presenta alla ribalta per l’applauso finale. Come in modo ancora più marcato fa in uno dei lavori più intriganti di questa mostra. Un autoritratto presentato dal titolo come un certificato anagrafico che segnala la sua età. 55 anni da poco compiuti. E impone a noi come unità di misura del suo percorso. Il buio in sala è ancora più fitto. Si intravede solo il caschetto di capelli e il rotondo inconfondibile del viso. A rubare lo sguardo sono solo i suoi occhi da demiurgo che si accendono e galleggiano ipnotici nell’oscurità.
Trasmettendo la stessa inquietudine, da scarica elettrica, che percorre i contorni dei suoi oggetti e in questi ultimi anni si è accentuata: una luce aguzza come una lama che si fa largo a spintoni, moltiplica di punti di fuga lo spazio e non tenta più di simulare un riflesso reale. L’arte come artificio, la vita come una lampadina che non sai da dove rubi energia e quando si spegnerà.
(2023)

“In tempi di insopportabile ‘armocromia’ Beatrice Cignitti dispiega invece davanti ai nostri occhi le mille sfumature che vanno dal nero assoluto al bianco, passando per i bagliori metallici dell’argento, evocato da un piccolo oggetto domestico.
Per questa artista che muove le durezze della grafite come fossero altrettante emozioni di una mano sapiente, ogni cosa piccola o grande che cade sotto il nostro sguardo è degna di attenzione, riluce di un chiarore spirituale.
Dall’impalpabile ‘nigredo’ nascono le istanze creative, si generano con mistero alchemico le molte figurazioni oniriche.
Troveremo, entrando in questo mondo, i volumi di Rodin, l’evocazione di un disegno che si fa scultura.
Ma soprattutto, avremo, a ben guardare, un sobbalzo, uno stupore, osservando una Pietà Rondanini rappresentata capovolgendone la lettura verticale; il grumo di dolore e amore che quest’opera immensa contiene è colto nell’ulteriore disfacimento della materia, nell’attimo prima in cui al tramonto la luce in una stanza sta per lasciare il posto alle tenebre.”
(1991)

La bellezza dell’entusiasmo preme e freme sotto la pelle del dipingere disegnando e del disegnare dipingendo di Beatrice Cignitti Questo stato di giovinezza mentale che coincide con questa prima giovinezza di fatto dell’artista (perché in alcuni è il contrario, infelici loro) resterebbe fìorescenza visiva senza un’altra situazione che è evidente, cioè risulta dall’opera: la bellezza della meditazione. Abbiamo come risultato fogli che vibrano di pensata gioia, di riposante corsa nella ricerca della verità poetica nelle apparenze. I fogli di Beatrice Cignitti diventano batuffoli di tenerezza e simultaneamente, ed è questo capacità d’arte, ritratti rigorosi della realtà come appare.
Il suo disegnare come il suo dipingere, e l’inverso, rischiano di diventare adulti, se non ci fosse un incantato alt, ch ‘è giovinezza poetica: l’artista scopre forme e segreti, luci e nascondigli per la prima volta: tunnel di verginità visiva, rara nell’arte dei giovanissimi di questi realistici decenni, realistici anche nelle avanguardie. Qui scatta la qualità attuale della nostra Cignitti. La nota biografica di Beatrice Cignitti include, può darsi al primo posto del suo passato e passaggio dalla vocazione alla realizzazione, il nome e la pittura di Enzo Brunori, come maestro. L’artista ne accetta con orgoglio la presenza. Che non c’è esplicita nella sua opera allo stadio di maturazione a cui sta arrivando.
Il nodulo realizzante è gomitolo proprio della Cignitti. C’è però l’avere appreso e capito, l’avere rielaborato nel proprio occhio, una limpida lezione. Brunori, uno dei primissimi ricercatori e reinventori dell’astrazione pittorica contemporanea, o dell’informale (comunque si voglia definire questa situazione di creatività italiana, autonoma) poteva anche influire soltanto formalmente sulla sua allieva. Questa, invece, con fulminazione di intuito, è andata sulla sua strada. Con alle spalle il maestro, è arrivata alla conclusione di produrre astrazione e informalità nel rigore delle luci e delle forme reali. Restano nella Cignitti le frantumazioni dello spazio in spazi inseriti nell’unità spaziale, quasi luci di vetrata divisoria e insieme unificante tra la luce di fuori e quella di dentro. La nostra Beatrice Cignitti ha inteso nel meglio il dettato del maestro. Oggi si presenta, in questa mostra di esordio o quasi, con le mani linde in offerta della propria personale vocazione, poggiata su una salda consapevolezza che l’arte è anche fatica, pazienza, scienza di misteriose esattezze coincidenti e confluenti nel mestiere del dipingere. Pure questo ha radici nell’insegnamento brunoriano. La Cignitti ha la qualità dello scatto dalla fatica dell’arte alla spensierata resa in poetica. Vedetela nei suoi spazi disegnati o dipinti. C’è più di qualcosa. C’è il richiamo all’indefinibile, attraverso il definito. In una giovanissima è un incredibile “molto”.
(2014)

“Sono io che ho suggerito la presenza di Beatrice Cignitti a questa edizione di Spoleto Arte: è una giovane disegnatrice piena di mistero che ho conosciuta anni fa, e che con  molto impegno e molta attenzione, e con una pazienza da antico pittore, da antico disegnatore, compone delle immagini di cui non capisci bene il senso, non c’è figurazione vera e propria, o c’è un’allusione a qualcosa che poi diventa pura immagine e puro pensiero.
molto impegno e molta attenzione, e con una pazienza da antico pittore, da antico disegnatore, compone delle immagini di cui non capisci bene il senso, non c’è figurazione vera e propria, o c’è un’allusione a qualcosa che poi diventa pura immagine e puro pensiero.
Volevo quindi ricordarla, avendola questa volta rivista e avendola già conosciuta”.
NEL GREMBO DELLA NOTTE (2016)
Se un giorno notturno e una notte diurna potessero abbracciarsi
“Bisogna rispettare il nero. Nulla lo prostituisce. Non deve piacere agli occhi o svegliare alcun senso. E’ l’agente della mente molto più del bel colore della tavolozza o del prisma”.
Odilon Redon
“… il disegno l’arte divina, base di ogni costruzione plastica, scheletro di ogni opera buona, legge eterna che ogni artefice deve seguire. Il disegno, ignorato, negletto, deformato da tutti i pittori moderni {…} il disegno, dico, tornerà non di “moda”, come oggi usan dire quelli che parlano di avvenimenti artistici, ma tornerà per necessità fatale, come una condizione sine qua non di creazione buona”.
Giorgio de Chirico

L’amplesso fecondo e inesauribile, talvolta conflittuale, fra luce ed ombra, fra notte e giorno, volti a dare forma al mondo, è l’autentico e sensuale protagonista delle opere di Beatrice Cignitti. E’ un’unione pulviscolare, atomistica, stretta in un abbraccio di particelle scintillanti, che danno corpo d’immagine ad un desiderio ascetico ma profondissimo. Come cantava Friedrich Schelling, “Se nella notte stessa sorgesse una luce, se un giorno notturno e una notte diurna potessero abbracciarsi, sarebbe infine lo scopo supremo di tutti i desideri”. E come sa bene Beatrice, il vero desiderio si nutre al tempo stesso di una presenza e di una assenza e quest’ultima, tramata d’invisibile, nutre i suoi disegni ed apre la porta al mistero. La memoria di un’assenza è del resto all’origine di quello che è ritenuto il mito fondativo dell’arte occidentale, basato tra l’altro proprio sul disegno: secondo una leggenda tramandata da Plinio il Vecchio nella sua “Naturalis Historia”, i Greci attribuivano l’invenzione della pittura, o meglio del disegno, ad una donna innamorata, la figlia di Butade Sicionio, un vasaio di Corinto, che per conservare un ricordo del suo amato in procinto di partire, “tratteggiò con una linea l’ombra del suo volto proiettata sul muro dal lume di una lanterna”. Così, si disegna veramente solo non vedendo o meglio, come nel caso della Cignitti, fuggendo la luce accecante del giorno per cercare le ombre della notte interiore e chiudere gli occhi per vedere, senza però rifugiarsi nel delirio della visione sradicata dalla realtà tangibile. E a tal proposito vengono alla mente i mirabili versi di Novalis, dagli “Inni alla notte”: “Ma più celesti/più ancora del brillio di tutte le stelle/ sfavillano in noi come occhi/infinite luci/ che la notte ci ha aperto nel cuore”. Su tale via, i disegni di Beatrice prendono forma come soglia fra interno ed esterno, fra visibile ed invisibile, fra apparizione e scomparsa, soprattutto nelle opere più recenti, quelle che hanno come riferimenti di partenza le sculture di Pietro Cenedella (artista bresciano del ‘900 che meriterebbe rinnovata attenzione) e soprattutto i lavori del titanico Auguste Rodin: mutatis mutandis, e pur nelle grandissime differenze di ricerca, in entrambi gli artisti emerge con chiarezza quella sorta di crescita organica della forma plastica che ha colpito Beatrice Cignitti. E d’altro canto la stessa scultura in marmo non fonda una parte fondamentale del proprio palpito vitale nella dialettica fra il bianco della materia e il nero delle ombre e dei vuoti? Se non ci si lascia ingannare dalle apparenze si scopre che il nero inseguito da Beatrice è sempre innervato dalla luce per sua mirabile natura e a ciò giova la profonda consapevolezza con cui l’artista usa la grafite, ben sapendo che essa, come ha spiegato Omar Galliani, “in origine è uno stato geologico che precede di milioni di anni, come compressione terrestre, il diamante, il minerale più puro e trasparente per eccellenza. La grafite sembra totalmente altro, appare nera come il buio, ma se la guardi è luminosa, riflette la luce”. Questo nero fotosensibile ed onnicomprensivo (non ci sono forse tutti i colori e volumi in potenza?) è fecondato da un lumen palpitante, un grembo che genera gli oggetti e le presenze che popolano il mondo intimo e appartato di Beatrice, la quale sempre più, col passare del tempo, sembra affrontare la sfida di “scolpire” questa luce nera col disegno, abolendo la linea che chiude e delimita e tentando di sottrarre all’oscurità dell’oblio quanto l’uomo e la natura hanno creato. Nelle forme affioranti dal buio, trepidanti per la propria fragilità, Beatrice Cignitti cerca conforto di fronte alla notte che incombe inevitabile sulle nostre esistenze. Incamminatasi con ascetica umiltà e ferrea tenacia, incurante delle mode, su una via che non ammette scorciatoie e che si tiene al difficile, quest’artista così sensibile (il cui stesso aspetto esteriore riflette gradevolmente la polarità “bianco/nero” del suo percorso creativo) aspira alla necessità assoluta che potrebbe unire indissolubilmente la tecnica e la materia con l’affioramento e lo svelamento del proprio essere più profondamente abissale ed autentico, in costante divenire. E’ la ricerca estenuante del creare raggiungendo quella sorta di naturalezza organica che si manifesta, ad esempio, in sommo grado nelle conchiglie, a cui Beatrice ha dedicato opere quanto mai avvolgenti, forse pensando anche alle inarrivabili riflessioni di Paul Valéry: “Un cristallo, un fiore, una conchiglia emergono dal consueto disordine dell’insieme delle cose sensibili e ci offrono stranamente unite, le idee di ordine e di fantasia, di invenzione e di necessità, di legge e di eccezione; nella loro forma troviamo, da una parte, la parvenza di un’intenzione e di un’azione che le avrebbe plasmate al modo in cui sanno farlo gli umani e, dall’altra, l’evidenza di processi a noi vietati e impenetrabili”. Valéry notava che la modalità con cui nasce la conchiglia è che “emana da un mollusco” e ciò la fa trasudare dai suoi pori sotto l’impulso di una necessità assoluta. “Forse – scriveva ancora l’insigne autore francese – quel che chiamiamo la perfezione nell’arte (che non è ricercata da tutti e che più d’uno disdegna) non è che il desiderio di trovare, in un’opera dell’uomo, questa certezza di esecuzione, quella necessità d’origine interna e quel legame indissolubile e reciproco della figura con la materia che la più piccola conchiglia mi mostra?”. Queste parole illuminanti di Valéry si adattavano perfettamente alla scultura di Rodin (come non pensare, ad esempio, a “La conchiglia e la perla”) le cui figure femminili sono le più recenti apparizioni proprio nei disegni di Beatrice, che ha colto istintivamente, nel corso del tempo, tale continuità plastico-organica fra forme necessarie: le conchiglie e le opere di un uomo che col marmo sapeva dire tutto di un corpo, fra presenza e assenza, attraverso la poetica del frammento. E così promana un eros soavemente notturno, tramato di un pulviscolo stellare, in questi corpi necessari, avvolgenti, che vien voglia di accarezzare nel buio, a occhi chiusi, prima che scompaiano, aspettando che il marmo si tramuti in carne e poi, ancora una volta, in traccia di mano che col disegno dà forma al mondo.
sempre innervato dalla luce per sua mirabile natura e a ciò giova la profonda consapevolezza con cui l’artista usa la grafite, ben sapendo che essa, come ha spiegato Omar Galliani, “in origine è uno stato geologico che precede di milioni di anni, come compressione terrestre, il diamante, il minerale più puro e trasparente per eccellenza. La grafite sembra totalmente altro, appare nera come il buio, ma se la guardi è luminosa, riflette la luce”. Questo nero fotosensibile ed onnicomprensivo (non ci sono forse tutti i colori e volumi in potenza?) è fecondato da un lumen palpitante, un grembo che genera gli oggetti e le presenze che popolano il mondo intimo e appartato di Beatrice, la quale sempre più, col passare del tempo, sembra affrontare la sfida di “scolpire” questa luce nera col disegno, abolendo la linea che chiude e delimita e tentando di sottrarre all’oscurità dell’oblio quanto l’uomo e la natura hanno creato. Nelle forme affioranti dal buio, trepidanti per la propria fragilità, Beatrice Cignitti cerca conforto di fronte alla notte che incombe inevitabile sulle nostre esistenze. Incamminatasi con ascetica umiltà e ferrea tenacia, incurante delle mode, su una via che non ammette scorciatoie e che si tiene al difficile, quest’artista così sensibile (il cui stesso aspetto esteriore riflette gradevolmente la polarità “bianco/nero” del suo percorso creativo) aspira alla necessità assoluta che potrebbe unire indissolubilmente la tecnica e la materia con l’affioramento e lo svelamento del proprio essere più profondamente abissale ed autentico, in costante divenire. E’ la ricerca estenuante del creare raggiungendo quella sorta di naturalezza organica che si manifesta, ad esempio, in sommo grado nelle conchiglie, a cui Beatrice ha dedicato opere quanto mai avvolgenti, forse pensando anche alle inarrivabili riflessioni di Paul Valéry: “Un cristallo, un fiore, una conchiglia emergono dal consueto disordine dell’insieme delle cose sensibili e ci offrono stranamente unite, le idee di ordine e di fantasia, di invenzione e di necessità, di legge e di eccezione; nella loro forma troviamo, da una parte, la parvenza di un’intenzione e di un’azione che le avrebbe plasmate al modo in cui sanno farlo gli umani e, dall’altra, l’evidenza di processi a noi vietati e impenetrabili”. Valéry notava che la modalità con cui nasce la conchiglia è che “emana da un mollusco” e ciò la fa trasudare dai suoi pori sotto l’impulso di una necessità assoluta. “Forse – scriveva ancora l’insigne autore francese – quel che chiamiamo la perfezione nell’arte (che non è ricercata da tutti e che più d’uno disdegna) non è che il desiderio di trovare, in un’opera dell’uomo, questa certezza di esecuzione, quella necessità d’origine interna e quel legame indissolubile e reciproco della figura con la materia che la più piccola conchiglia mi mostra?”. Queste parole illuminanti di Valéry si adattavano perfettamente alla scultura di Rodin (come non pensare, ad esempio, a “La conchiglia e la perla”) le cui figure femminili sono le più recenti apparizioni proprio nei disegni di Beatrice, che ha colto istintivamente, nel corso del tempo, tale continuità plastico-organica fra forme necessarie: le conchiglie e le opere di un uomo che col marmo sapeva dire tutto di un corpo, fra presenza e assenza, attraverso la poetica del frammento. E così promana un eros soavemente notturno, tramato di un pulviscolo stellare, in questi corpi necessari, avvolgenti, che vien voglia di accarezzare nel buio, a occhi chiusi, prima che scompaiano, aspettando che il marmo si tramuti in carne e poi, ancora una volta, in traccia di mano che col disegno dà forma al mondo.
IL BAGLIORE SEGRETO DELLA REALTA’ (2023)
Noi ci affanniamo sempre. / Ma il progresso del tempo / consideratelo una smagliatura / di quel che sempre resta
Rainer Maria Rilke
 Indifferente al succedersi delle mode, dei vari vetrinismi, delle fabbriche dismesse trasformate in installazioni e via discorrendo, Beatrice Cignitti continua a tessere sapientemente segni di luce umbratile che rigenerano il mondo, i corpi, gli oggetti, facendo dialogare il giorno e la notte. Come un amanuense d’altri tempi, salva il salvabile partendo dalla sapienza della mano demiurgica e senziente. Con un’ipersensibilità quasi medianica, Beatrice vede l’aura perfino in quest’inizio di terzo millennio così ferocemente tecnologico e pragmatico. È una rabdomante di magie quotidiane, semplici, e anche per questo ancora più sorprendenti. Così tutto si ammanta di un mistero avvolgente, dolce, trepidante, nella preziosa solitudine della sua vita e della sua ricerca. E sempre di più, in questi anni recenti, soprattutto nelle matite ispirate all’amato Rodin, il suo segno supera qualsiasi linearità bidimensionale per farsi plastico e costruttivo, pur conservando la sua vibrante musicalità. Lo vediamo nei tre piccoli nudi “Danaide”, “Faunessa” e “Cariatide con urna” e nella grande figura con la “Centauressa”, in cui la frequente applicazione di un’evocativa poetica del frammento emana il suono di un mondo perduto mentre il mito suggerito dalle loro pose si attualizza nel presente con una seducente carnalità. E non a caso Beatrice ama ricordare una preziosa riflessione lasciata da Rodin nel suo testamento: “Tutti i grandi sondano lo spazio. E nella nozione di spessore che risiede la loro forza. Ricordatevi di questo: non vi sono linee ma solo volumi. Quando disegnate, non preoccupatevi mai del contorno, ma del rilievo. È il rilievo che regge il contorno”. Ma i volumi immaginati da Beatrice nascono da un’irradiazione quasi atomistica e stellare innescata da un lavoro lungo, certosino, paziente, pulviscolare, che vive di un senso del tempo orientato sui ritmi vitali della natura e non su quelli assurdamente frenetici di un oggi obliante. La meraviglia dell’intimità con il soggetto scelto si unisce all’amore per lo sguardo prolungato: l’artista ci invita a contemplare pazientemente ma, allo stesso tempo, a muovere l’occhio per scoprire qualcosa di unico negli enigmi del visibile. E poi le opere di Beatrice esaltano, come quasi mai accade con altri artisti contemporanei, il senso del tocco, per così dire, un’eccellenza del tatto inteso come azione fluida e delicata, che proviene dall’interiorità, tanto da donarci l’illusione feconda di poter toccare perfino la luce e l’ombra.
Indifferente al succedersi delle mode, dei vari vetrinismi, delle fabbriche dismesse trasformate in installazioni e via discorrendo, Beatrice Cignitti continua a tessere sapientemente segni di luce umbratile che rigenerano il mondo, i corpi, gli oggetti, facendo dialogare il giorno e la notte. Come un amanuense d’altri tempi, salva il salvabile partendo dalla sapienza della mano demiurgica e senziente. Con un’ipersensibilità quasi medianica, Beatrice vede l’aura perfino in quest’inizio di terzo millennio così ferocemente tecnologico e pragmatico. È una rabdomante di magie quotidiane, semplici, e anche per questo ancora più sorprendenti. Così tutto si ammanta di un mistero avvolgente, dolce, trepidante, nella preziosa solitudine della sua vita e della sua ricerca. E sempre di più, in questi anni recenti, soprattutto nelle matite ispirate all’amato Rodin, il suo segno supera qualsiasi linearità bidimensionale per farsi plastico e costruttivo, pur conservando la sua vibrante musicalità. Lo vediamo nei tre piccoli nudi “Danaide”, “Faunessa” e “Cariatide con urna” e nella grande figura con la “Centauressa”, in cui la frequente applicazione di un’evocativa poetica del frammento emana il suono di un mondo perduto mentre il mito suggerito dalle loro pose si attualizza nel presente con una seducente carnalità. E non a caso Beatrice ama ricordare una preziosa riflessione lasciata da Rodin nel suo testamento: “Tutti i grandi sondano lo spazio. E nella nozione di spessore che risiede la loro forza. Ricordatevi di questo: non vi sono linee ma solo volumi. Quando disegnate, non preoccupatevi mai del contorno, ma del rilievo. È il rilievo che regge il contorno”. Ma i volumi immaginati da Beatrice nascono da un’irradiazione quasi atomistica e stellare innescata da un lavoro lungo, certosino, paziente, pulviscolare, che vive di un senso del tempo orientato sui ritmi vitali della natura e non su quelli assurdamente frenetici di un oggi obliante. La meraviglia dell’intimità con il soggetto scelto si unisce all’amore per lo sguardo prolungato: l’artista ci invita a contemplare pazientemente ma, allo stesso tempo, a muovere l’occhio per scoprire qualcosa di unico negli enigmi del visibile. E poi le opere di Beatrice esaltano, come quasi mai accade con altri artisti contemporanei, il senso del tocco, per così dire, un’eccellenza del tatto inteso come azione fluida e delicata, che proviene dall’interiorità, tanto da donarci l’illusione feconda di poter toccare perfino la luce e l’ombra.
Il passaggio, pur sempre coerente, da una fase più nitidamente analitica a quella attuale, plastico-scultorea, è testimoniato in mostra dal confronto fra le tre grandi carte (mai esposte finora) dei primi anni dieci (“Nautilus”, “Vetro rosso” e “Panneggio e scatola rossa”) e le opere più recenti. Nell’un caso e nell’altro, la sua “verità” è estatica, poetica ed elusiva, fatta di domande e senza risposte. Del resto, come profeticamente dice Robert Musil ne “L’uomo senza qualità”, “…la voce dei conti e dei calcoli oggi s’oppone dappertutto alla grandezza della vita, al mistero del sentimento”.
E proprio perché si intona spontaneamente a questi ultimi elementi, ora negletti, l’arte di Beatrice Cignitti sembra (felicemente, lasciatemelo dire) inattuale, fuori dal coro, vestita di una sua purezza di visione che cerca la scintillazione nelle tenebre, usando semplicemente la matita su carta. Lei si tiene al difficile, come consigliava Rilke in “Lettere a un giovane poeta” e non cerca scorciatoie basate su facili trovate. Beatrice cerca l’incanto anche guardando un caricabatterie, un panneggio, una matita, una scatola. Sa ancora stupirsi di fronte alla magia del quotidiano. Sembra accordarsi mirabilmente con quanto Rodolphe Bresdin suggeriva ad Odilon Redon facendo l’esempio del comignolo: “Vedete questo fumaiolo, che cosa vi dice? A me racconta una favola. Se avete la forza di osservarlo bene e di capirlo immaginate il più strano e bizzarro dei soggetti. Così il vostro sogno sarà vivo. L’arte è lì”. E non a caso lo stesso Redon arrivò a scrivere in “A soi-mème”: “I miei disegni ispirano e non definiscono. Non determinano niente. Ci collocano, come la musica, nel mondo ambiguo dell’indeterminato. […]
Il senso del mistero è l’essere continuamente nell’equivoco, nei doppi e tripli aspetti, indizi di aspetti (immagini nelle immagini), forme in divenire o che si configurano a seconda dello stato d’animo di chi guarda. |…] Ho messo nelle mie opere una porta aperta sul mistero”. Beatrice Cignitti è certamente un’artista dell’immaginario ma mai dell’eccentrico o dell’eccessivo, perché resta ben radicata nella realtà tangibile. Costruisce il visibile scolpendo col segno nell’invisibile, dandogli un respiro e al contempo una plasticità vibrante. Compie un cammino solitario perché ha scelto la via della necessità interiore, proprio quella da cui la maggioranza della gente rifugge per inseguire lo stordimento narcisistico dei social e di una pervasiva retorica tecnologica. Per lei tutto è degno di attenzione ed ammirazione, ogni cosa ha il suo “daimon”, il suo bagliore segreto che la fa rifulgere se si sa vedere oltre le apparenze e le convenienze. Perché, in realtà, tutto sta nel nostro sguardo più che nelle cose in sé stesse, e quello di Beatrice, come si vede nell’ipnotico “Autoritratto a 55 anni”, è nutrito dall’anima, parte da molto lontano, da profondità abissali legate alla sensibilità, per attingere anche alla memoria, infine arrivando verso l’esterno e tutto trasfigurando con una sorta di respiro luminescente. Così la tecnica arriva ad identificarsi col sentimento. Il foglio di carta non è terreno di scontro per gestuali psicomachie né per fredde progettualità o aridi citazionismi ma si dispone come un nido, un ricettacolo accogliente per la fioritura di segni a grafite che danno un corpo auratico al mondo esterno riunificandolo e ridestandolo in una nuova unità che purifica e supera quella serie di discontinuità, di differenze, di conflitti con cui la realtà stessa si presenta. Si ha come l’impressione che un’energia centripeta raggrumi infiniti atomi dispersi nel caos dandogli un senso inedito e poetico, prima che si sparpaglino definitivamente finendo nell’oblio e nel nulla. Così Beatrice trova nelle apparenze del mondo un mistero gentile, accogliente, trepidante, mai minaccioso o apocalittico. Usando la sua matita come una bacchetta magica, la nostra artista rivela che tutto è prezioso, se si ha la ricchezza interiore per rendersene conto.
(1996)
 Beatrice Cignitti sta attraversando, direi con successo, una fase cruciale nella sua evoluzione di artista; si è bene inoltrata, cioè, sulla via del superamento dell’esperienza compiuta all’Accademia di Belle Arti di Roma (ed anche oltre) sotto la guida di un Maestro amatissimo e quanto mai assorbente quale Enzo Brunori, per precisare una propria originale voce, una propria genuina natura di pittore.
Beatrice Cignitti sta attraversando, direi con successo, una fase cruciale nella sua evoluzione di artista; si è bene inoltrata, cioè, sulla via del superamento dell’esperienza compiuta all’Accademia di Belle Arti di Roma (ed anche oltre) sotto la guida di un Maestro amatissimo e quanto mai assorbente quale Enzo Brunori, per precisare una propria originale voce, una propria genuina natura di pittore.
Ecco così riaddensarsi i nuclei figurativi che prima, in una felice ripresa di moduli “puntinisti”, si erano come dissolti nel turbine quasi astratto della cromia, ecco così riacquistare una fisionomia gli elementi vegetali e naturali (piante e fiori ma anche conchiglie e altri oggetti) che sono il felice pretesto della sua attuale pittura. Con questo processo di ridefinizione dell’immagine si viene a saldare la strana dicotomia tra la precedente pittura della Cignitti, stordita nell’ebbrezza panica del colore, e il suo disegno, sorgente da un nero di tenebra come un sottile fiato di luce, rigorosamente figurativo, “magico” in senso metafisico, esattamente, puntigliosamente definito e calibrato in ogni dettaglio eppure onirico e misterioso, con qualche parentela col disegno di Seurat e più ancora con quello di Redon.
Ma torniamo alla pittura, che al momento è quanto sembra preoccupare l’artista in modo pressocché esclusivo. Detto del rinsaldarsi delle immagini rappresentate in questi quadri e in queste tempere, rimane da osservare come il punto di riferimento culturale dell’artista – che prima era la pittura divisionista, insieme a quel modo di scomporre luci e sensazioni cromatiche tipico di Enzo Brunori – oggi sia in maniera abbastanza esplicita il “fauvisme” e soprattutto Matisse, con semplificazioni di forme estremamente sintetiche e “tagli” perentori di luce e di colore. Certo, sono quadri tutt’altro che drammatici, di un’eleganza raffinata da far pensare al primo Dufy, ma quadri fermamente concepiti e dipinti, con un’architettura essenziale e insieme fantasiosa,
A partire da questi risultati, così elegantemente risoluti e netti, non è difficile preconizzare alla Cignitti un cammino sempre più audacemente personale. L’esperienza scolastica è ormai ben lontana alle sue spalle, sicché non v’è che inoltrarsi sempre più decisamente nei territori perigliosi e frastornanti della militanza artistica. Hic sunt leones, lo sappiamo bene, ma la nostra giovane artista ha doti di cultura e capacità di mano in grado di farla felicemente sopravvivere.
(2001)
Jede Kunst basiert auf beherrschtem Handwerk, und das ist die Stärke Cignittis. Der Bleistift wird ihr zur verlängerten Hand. Mit ihm formt sie Blüten, Glas und Muscheln in zarte Strichlagen, dicht versponnen zu einem silbrigen Gewebe aus Licht und Körperschatten. Ein sanftes Mondlicht scheint die Dinge zu umfangen und ihnen magische Kräfte zu verleihen. Die kleinen Gebrauchsutensilien verlieren ihre Banalität zugunsten meditativer Reinheit. Ein Wasserglas, eine Weinflasche, ein belangloses Döschen – sie werden makellose Schönheit. Alpenveilchen und Sanseverien konservieren ihr Wachstum im Dornröschenschlaf des sie umgarnenden Strichgefüges <…>. ,,Notturni für Solo-Bleistift“ nannte der Kunstkritiker Marco Di Capua die Zeichnungen seiner Landsfrau. Ein treffender Vergleich für die Stillleben im Vollmondschein aus Grafitmine auf kostbarem Fabriano-Bütten.
Beatrice Cignitti – Tutti i diritti riservati © 2024
WebDesign Pino Mannarino by StyleFactory
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.